E’ una novità editoriale il fascicolo del 2019 della rivista ‘L’Ellisse. Studi storici di letteratura italiana’ (Anno XIV, 2019/2), edita dall’«Erma» di Bretschneider: dedicato a “Marino e l’arte tra Cinque e Seicento” e’ a cura di Emilio Russo, Patrizia Morsini e Andrea Zezza.
Gli autori del prezioso libro sono molti di più e non solo fra i nomi che abbiano fatto testo negli ultimi anni nella critica letteraria italiana - il parametro della rivista - o abbiano in precedenza affrontato l’enigmatico Giovan Battista Marino. Fra di loro vi sono, infatti, anche ascoltati storici dell’arte propriamente detti, che abbiano accolto il filone del continente neolatino, in cui non solo l’intento programmatico della rivista è immerso, ma tanto l’arte, quanto la storia dell’arte italiana non avrebbe potuto non esservi schierata, ‘suora gemella’ della filologia fin dalle origini.
In questo libro per una volta anche la poesia è storia dell’arte, in cui la memoria visuale, fatta di allegorie e metafore, ha nei propri segni nomi e cognomi a caratteri tipografici, ma vorremmo dire di più, l’opera d’arte diventa testo piu’ che paradossale documento. Un testo ambiguo, o meglio per s-definizione penetrante gli equivoci della prosa, attraverso la concordanza, seppure dimostratamente esile, delle immagini poetiche al copioso epistolario e, nella cifra diaristica, allo Zibaldone di Marino, nell’assidua ricerca dei commentatori da una dimensione propriamente lirica di sincretismi appropriati tra materiali di lavoro tecnicamente autonomi, metalinguistici da struttura a struttura. D’altra parte, la storia dell’arte, nella convinzione che ogni oggetto artistico sia documento storico, ha sempre compiuto lo stesso raffronto descrittivo tra le varie tecniche artistiche fra loro, anche di opere lacunose o scomparse, con le poche notizie sui singoli artisti, spesso frantumate d’improvviso da un nuovo testo o da un altro oggetto, che può mostrarsi nel tempo ancora parziale e irrilevante, ma che ne scompagina sempre il mosaico bibliografico.
Sulle corrispondenze che sono risultate delle sue ottave ad oggetti d’arte concretamente pervenuti fino a noi, si sostanzia il lavoro critico degli autori dal versante letterario: un lavoro senza esitazioni di recupero immane, di ricostruzione documentale dell’iconologia barocca di cui il poeta è caposaldo, e non solo in parallelo all’Adone, ma alle diverse e innumerevoli edizioni delle sue rime.
Ne e’ scaturito il trionfo di una conoscenza spropositata degli argomenti dell’arte e di passioni archetipiche, che non sarà contraddetta nel corso del Seicento nemmeno da Giovanni Baglione, che oltre a Giorgio Vasari, e a Giulio Mancini e Gaspare Celio sullo scorcio del secolo, della storia dell’arte italiana - specialmente dell’arte sacra - vanta il pilastro di fondazione piu’ solido, se non il piu’ edificante.
Il saggio di Clizia Carminati e’ rivolto alle dibattute pubblicazioni postume del carteggio di Marino, edito dal 1627 al 1629, precisando, in rapporto all’edizione originale delle Lettere nel 1628, una tavola dei ‘Nomi dei pittori che hanno favorito il Cavalier Marino nell’edizione della sua Galeria’, confrontabile e parallelo al “Racconto de’ pittori” de La Pittura trionfante di Gigli del 1615. Dall’elenco, da Marino stesso modificato nel corso di un decennio, risalta non ovviamente come vi fossero esclusi i pittori già morti nel Seicento, al momento della sua prima stesura, ad esempio Agostino Carracci e Michelangelo da Caravaggio, i piu’ approfonditi sulla frontiera storico artistica, ma con i quali non intrattenne, come finora presupposto, un rapporto di committenza propriamente detto ed ai quali non richiese o dai quali non ricevette personalmente scambi od omaggi di opere. Certo non esclude che i due pittori avessero lavorato entrambi a Roma per profitto privato e vi avessero avuto l’iniziativa del fiorente commercio artistico di fine Cinquecento, in prima persona o avvalendosi di agenti, bottegai e procuratori (Richard Spear 2016). Elenco significativo per gli anni trascorsi dal poeta a Ravenna al seguito del cardinale Pietro Aldobrandini, dal 1605 al 1608, sia per Ludovico Carracci che per i pittori toscani emergenti e altrettanto inclusi dalle bene informate biografie di Giovanni Baglione: a fuoco gli artisti senesi Francesco Vanni e Ventura Salimbeni, sempre impegnati nel primo decennio del Seicento nella produzione commerciale, con i quali Marino aveva avuto una corrispondenza epistolare, e da lui scelti nella rosa degli artisti sul piano del collezionismo personale. Sebbene nel libro presentato sia stata considerata la pretesa di conformismo retorico del marinismo agli ‘entourages’ accademici dei rispettivi mecenati, piu’ di qualche volta gli stessi, alcuni dei pittori che sono acclusi nel suo elenco, invece, patronimico compreso, mancano tuttora di visibilita’ negli indici e cataloghi piu’ attuali, non solo nell’ambito territoriale e geografico europeo, perduti già dall’Ottocento. Tra questi il pittore milanese Giovan Battista Serrano, che egli chiama “Serano”, famoso per aver dipinto un soggetto con le Muse, e storicamente privo di altra notorietà, se si fa eccezione per l’opera piu’ tarda di Raffaello Soprani. Inoltre, Lucilio Gentiloni da Filatrava (Filottrano), che, se non per il fatto di essere stato sarcasticamente apprezzato da Marino, come tale sarebbe pur sempre irriconoscibile nei lacunosi regesti documentari dei cantieri anche emiliani, come Novellara, in cui avesse svolto la sua piu’ rinomata attività a fianco di artisti piu’ congeniali alla critica dei due secoli scorsi.
In realtà, tutto il recentissimo numero della rivista L’Ellisse verte su un’opera sola del poeta: La Galeria del Cavalier Marino. Distinta in Pitture & Sculture, come spiega Marco Landi nel saggio intitolato ‘Per una nuova edizione de La Galeria’, affrontando criticamente l’edizione veneziana di Giovan Battista Ciotti del 1620, nell’arco di tempo di un decennio, in cui questo sistema complesso venne preparato alle stampe (stampata nel 1619), composto com’è da una raccolta di odi, madrigali e sonetti, cioé di poesie su dipinti e sculture di “valent’uomini” - un lessico proprio ai Veri Precetti della pittura di Giovan Battista Armenini, ormai diffuso alla fine del Cinquecento - e performanti una galleria ideale di preziosità contemporanee, nella quale regnino lo straordinario e l'eccesso.
La fortuna editoriale de La Galeria, seconda solo a quella dell’Adone, può dirsi, quindi, un indicatore del successo di un proficuo commercio di opere d’arte, frequente sul crinale del secolo non solo nelle corti principesche e ducali, ma fra la borghesia gentile, tanto negli edifici religiosi che nelle case private. E del dilagare di un altro ozio eccentrico, nel quale era sfociato il nuovo benessere, quello del visibilio giambico dello scherno, il genere satirico, ma soprattutto il visibilio malinconico della moderna canzone d’amore, favorito da forme di aggregazione accademica e corporativa, oltre che oratoriana, conventuale ed ecclesiastica. Il poeta non si propone come riformatore distante, ma come partecipe creatore di genio alla recitazione in ogni occasione d’intrattenimento, dentro e fuori il cerimoniale e la liturgia solenne: gli spettacoli e i concerti, le pubbliche letture, il gioco, il ballo e il passatempo dell’elegia in musica. Riguardo tale sfoggio di baldanza, non solo cortese e conviviale, Marino consegna un elenco decifrato di committenti, tutt’altro che sconosciuti sotto quest’aspetto pubblicistico, come Ferdinando Gonzaga, ma tra i piu’ ampi che si possano immaginare attraverso la ‘damnatio memoriae’ dei contemporanei verso la quale sola si dimostra irriverente, al pari dei piu’ celebri libertini.
Le esasperate proteste del poeta verso l’edizione di Ciotti, una “semplice mercatura”, a suo dire, malcelano lo scabroso plagio dei testi ricevuti da parte dei tipografi, ai quali l’editore dovette venderne i diritti all’insaputa di Marino, esule a Parigi e che la stamparono, in tutto o in parte, tra Milano e Ancona. Non solo perché fitta ancora di errori più di altrettante prove di stampa, ma perche’ le altre due edizioni pirata furono diffuse prima che il poeta potesse licenziare la stessa veneziana nel 1620, avutone da Ciotti il manoscritto l’anno prima.
Abbandonando la struttura biografica delle Vite degli artisti di Giorgio Vasari, La Galeria ne mantiene, tutto letterario, il registro autobiografico di rivendicazione creativa della trama di rappresentazione delle opere anche di contemporanei. Tendendo agli universali dell’Iconologia di Cesare Ripa, la cui prima edizione è del 1593, se ne discosta, non solo perché Marino non abbia più illustrato la sua ‘editino princeps’, ma perché ciascuna poesia è con rigore quasi sempre pertinente ad un pezzo in particolare da riscoprire con i suoi occhi. Senza un preciso intento didascalico proprio perche’, a differenza di Emanuele Tesauro, l’operetta consiste per ciascuno dei suoi madrigali principalmente di ardimentosa e arguta affabulazione analogica, tendenziosa quanto di testimoniale introspezione: un registro autobiografico che sarà ancora più vivo nell’Adone.
Di queste opere in molti casi non si ha oggi altra memoria visuale, se non la certezza che alla data di pubblicazione del poema, edizione corrotta o no, ciascuna di cui avesse scritto fosse determinata dall’osservazione, anche solo attraverso una descrizione o un disegno, per il quale mostrava una predilezione spiccata, oppure ancora un’incisione o anche una personale, dettagliata, commissione di una copia per sé, documentata a volte da una lettera. Non soltanto quindi immaginata nella parafrasi e nell’ecfrasi delle fonti classiche e alessandrine, e ad esse concordante nell’eccesso e nell’iperbole, ma anche museografica o in procinto di essere collezionata, se già non lo fosse stata: su tutte le pitture il topico primato della poesia.
Due le Dediche del 1619 da Parigi dell’edizione seicentina, una nella seconda parte delle Sculture, al marchese Luigi Centurioni, altrimenti celebre per essere stato il committente degli affreschi di Bernardo Strozzi nella Villa di Sampierdarena e nel palazzo in Strada Nuova a Genova. E l’altra nella prima parte delle Pitture, rivolta in apertura di libro a Giovan Carlo Doria, quale mecenate di Marino e non solo collezionista di una cospicua raccolta, come osserva nel testo appena uscito Carlo Caruso.
Una parte della collezione Doria era nella residenza romana di Palazzo Spinola in Borgo Vaticano almeno dal 1608, in cui Giovan Carlo sposò Veronica Spinola ed anno in cui Marino, al seguito del cardinale Pietro Aldobrandini dal 1603 - quest’ultimo non certamente a Roma residente nell’odierno Palazzo Chigi - ando’ a Torino, e mentre Pieter Paul Rubens lavorava agli altari della chiesa di S. Maria in Vallicella.
Alla galleria misteriosa, fatta dell’ardore amatoriale di uno stesso consulente, idealmente prediletta nel suo girovagare e composta non solo di versi, il volume “Marino e l’arte tra Cinque e Seicento” in qualche caso aggiunge opere denominate al dovizioso nucleo di oggetti d’arte ritrovato dal poema, corredandolo di un inserto di illustrazioni, non sempre condivisibile ‘tout court’, ma nient’affatto noiosamente ridondante allo scopo di penetrare semanticamente nell’uno come nelle altre.
Tra le riproduzioni di opere riconosciute e accluse dagli autori spicca l’Atalanta e Meleagro di Rubens al Metropolitan Museum of Art di New York (fig. 2), il “Meleagro e Atalanta di Pietro Paolo Rubens” negli endecasillabi de La Galeria. Il quadro è anche riprodotto da un’acquaforte bulinata in controparte di Cornelis Bloemaert nello stesso museo, non datata, e inscritta: ‘P. P. Rubens pinxit’, poiche’ Rubens esegui’ il disegno dell’intaglio, che definisce anche la fonte del soggetto come tratto dalle Metamorfosi di Ovidio.

Fig.2 - Pietro Paolo Rubens, Atalanta e Meleagro (Metropolitan Museum of Art, New York)
Il mancato ritrovamento di un ritratto di “D. Veronica Spinola, insieme con Giovan Carlo Doria suo marito”, quest’ultimo personaggio raffigurato anche dall’incisione parigina di Michel Lasne col disegno di Simon Vouet del 1620 (National Gallery of Art, Londra), lascerebbe ancora ipotizzare che l’autentico artefice del ritratto storico esaltato da La Galeria sia da ricercare unicamente nella consistenza dei versi mariniani, modello lirico di canzone imperitura non unico del poema, ma singolare nel doppio ritratto immortalato. Simon Vouet aveva dipinto Marino stesso e Marcantonio Doria, ma solo il ritratto di quest’ultimo è considerato ancora originale.
L’attendibilità di un ritratto del poeta ad opera di Simon Vouet risiede, invece, nell’incisione (fig. 3), in numerevoli esemplari sempre in ovato (Rijksmuseum, Amsterdam), di Johann Friedrich Greuter (1590 ca. - 1662) disegnata da Simon Vouet, eseguita a Roma, e per la quale fu Marino a dettare, di sapore virgiliano, il versetto agiografico: “Si tua vita Marine, leves est lapsa per umbras, clarior ex umbris en tibi vita redit”, con l’accenno alla redenzione dalle ‘lievi’ ombre che avevano circondato la sua persona, quindi stampata dopo che aveva ricevuto la croce di cavaliere da Carlo Emanuele di Savoia, come ricorda l’iscrizione e che sarà la stessa inserita ne La Strage degli innocenti, pubblicata postuma dal nipote Francesco Chiaro a Venezia (1633): agli incisori Matthaus e Johann Friedrich Greuter dedico’ una biografia Giovanni Baglione.

Fig. 3 - Johann Friedrich Greuter, da Simon Vouet, incisione
E ancora di un ritratto genovese di Giovan Battista Marino del pittore Luciano Borzone, eseguito in una delle improvvisate a Genova del poeta, parlò Raffaello Soprani nelle sue Vite (1768, 2a, Volume I, p. 250), che nemmeno è, però, tra quelli del poeta cantati ne La Galeria. Un parallelismo tra opera d’arte, mito e allegoria, cioe’ favola e ritratto storico si fa strada con maggiore consistenza ogni volta che una sua immagine diventa concreta.
Nella collezione di Giovanni di Sangro, principe di Fondi, inoltre Gaetano Nobile, nella Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze (Napoli 1845, II, p. 335), registrava “il ritratto del cavalier Marini del Caravaggio”, che Maurizio Marini collegava alla tela, da decenni irrintracciabile, in collezione privata londinese e che, sebbene altrettanto priva della croce di cavaliere e della corona d’alloro, come si evince dalla riproduzione fotografica nota, e’ incomparabile anche al ritratto di Simon Vouet. Volendo considerare che questo dipinto, pubblicato in collezione londinese da Marini (2005, tv. 44), sia il ritratto della raccolta di Sangro, e’ pur vero che della personalità romantica, narcisistica ed emblematica, in una parola indiscreta, del poeta ha solo la posa e l’astrazione di un’eleganza lombarda. Certo non può essere lo stesso di Caravaggio, in cui Marino s’identificava ancora nel 1620 ne La Galeria.
Che le vive effigi a mezza figura, fisicamente attraenti, dell’armonia corporale della giovane coppia di marchesi, vanto nell’Accademia del nudo, fossero proprio il tripudio dell’Atalanta e Meleagro di Rubens a New York (fig.2), avvicina alla tragedia del mito l’apoteosi del contrasto amoroso nei due distinti madrigali dedicati ai coniugi da Marino: ritratti da Rubens e da lui stesso. Ma un doppio ritratto era stato dipinto anche da Caravaggio ne La Buona Ventura (Musei Capitolini, Roma) con il tema del reciproco inganno dei due amanti nella promessa di matrimonio, in cui era effigiato il drammaturgo Giulio Strozzi, beneamato anche da Marino, e, dai capelli castani, Fillide Melandroni. Nel dipinto a New York (fig.2) la preda della pelle di cinghiale e sul fondo, accanto ad un battitore con un corno da caccia, il volto scuro di una Parca e’ presagio del tragico destino di Meleagro, monito alle giovani coppie. Una filigrana che conferma l’idea della galleria di ritratti di uomini e donne illustri, encomi tra storiografia e mitografia (Marco Corradini 2020), e pittura, di corte in corte sviluppata da Marino molto prima di dare alle stampe il Panegirico di Carlo Emanuele I di Savoia nel 1608, che gli consentì di prevalere nelle grazie del monarca nella competizione con Gaspare Murtola. La ‘damnatio memoriae’ ha riguardato anche la favola successiva al Meleagro di Rubens, “Attheone divorato da’ cani di Bartolomeo Schidoni”, che è possibile soltanto immaginare nella bizzarra tela di Palazzo Caetani (fig.4), recentemente pubblicata (Ilaria Sferrazza 2017), dove Atteone, nel grandioso paesaggio, avrebbe certo meritato, in un microcosmo degno dei Bamboccianti, ma nella scala di un telero veneto, l’epiteto parodico del più misero dei mortali mai dipinto in un idillio pastorale. Se la smisurata tela fosse stata concepita come uno scenario teatrale, o utilizzata in seguito a questo fine, non risulta dagli archivi Caetani, né che il cardinale Antonio Caetani o il duca di Sermoneta Filippo, commediografo, ai quali Marino dedicò un’“Heroica” nelle Rime del 1602 (p. 129), acquistassero la tela dal pittore che aveva eseguito alcuni dipinti nel Palazzo del Giardino di Parma di Ranuccio Farnese.

Fig. 4 - Bartolomeo Schedoni (?), Diana e Atteone (Fondazione Palazzo Caetani, Roma)
Marino elogia opere d’arte, anche quando degne di pungente derisione, fondando la descrizione artistica per capolavori, il ritratto dal vero dell’opera d’arte, che vive per se’, in una parola l’iconografia nel contrapposto poetico, classificandone nell’inventario appassionato genere, materia e stile, ma più che un catalogo o una bibliografia di recupero filologico degli scenari di poeti antichi e moderni è un film di sequenze interpretate da protagonista, di ‘admiranda’, in cui vige il paragone alla realtà di un vissuto grandioso quanto madornale, osservato con il distacco di un rifugiato e in cui risaltano i moderni frequentati piu’ da vicino.
Non c’è dubbio che l’opera a stampa di Ripa fosse presente ai pittori di cui il poeta parlava e che da questa enciclopedia di universali fossero volutamente esclusi da La Galeria le “primizie”: cioé i fiori, i frutti e le insalate, figurativo al quale era fatto esplicito riferimento da Marino nella dedica a Melchiorre Crescenzi delle Rime del 1602 (Parte 1), con dedica di Ciotti del 1601. Pur ricorrendo ovunque nel testo poetico a fiori e frutti, una sola ottava è dedicata ad una natura morta, intitolata "Frutti di mano d'una donna", tra i Capricci, da sempre collegata alla pittrice trentina Fede Galizia, che sola poteva aspirare ad incarnarsi, nell'anonimato dei versi, nella natura stessa, al femminile per antonomasia. Alle nature morte, i flagranti ‘naturalia’ in stile romano dedicherà particolare erudizione il libello del ‘Musaeum’, edito nel 1626, del cardinale Federico Borromeo, che aveva ricevuto l’omaggio prezioso e realmente più rappresentativo non solo di vasi di fiori fiamminghi, ma di fiori e frutta caravaggesca, acquisita tramite D’Arpino, oppure il suo agente Jan Brueghel il Vecchio detto dei Velluti, o i Crescenzi, se non i duchi Mattei, il cui palazzo era vicino al Convento romano di S. Ambrogio, come ricordava anche Giulio Mancini. Anche volendo tralasciare l’estesa corrispondenza tra Marino e Girolamo Borsieri, sovrintendente della Pinacoteca Ambrosiana, museo che ancora deve il suo titolo di ‘pinacoteca’ a Petronio Arbitro, non e’ facile non cogliere in questo lavoro critico su La Galeria di Marino i nessi all’opera di Borsieri, con l’immancabile riferimento che contiene al Trattato delle pitture e all’Idea del Tempio della pittura del 1590 di Giovan Paolo Lomazzo. Era Lomazzo, pittore e biografo, ad attribuire alla pittura di Leonardo il primato, oltre allo studio del corpo umano, di dipingere le cose minori “…che occhio mortal niente piu’ sa’ desiderare” e alla carta, supporto del disegno, il privilegio di conservarsi nel tempo e di soddisfare il desiderio di possesso di opere conosciute anche solo attraverso l’incisione. Ed era l’Iconologia di Ripa nell’icona universale della Fecondità a citare il Meleagro di Euripide e il suo frammento contenente il pronostico di perenne felicita’ alle coppie genitrici, che precipitava un contenuto etico, il matrimonio riparatore, contraltare del matrimonio combinato, precettisticamente sentito al tempo, in un’immagine altrettanto avvertita di erotica floridita’.
Lode non meno sviscerata e astrattamente impennata alla virtù di ogni diva della letteratura che sia stata predicata, eretta sui “vergognosi amori” di Elena e Didone (che Giosuè Carducci dirà l’“Eterno femminino regale”, 1882) e’ pero’ Il Tempio di Giovan Battista Marino, il panegirico alla sovrana di Francia Maria dei Medici, che reca nel frontespizio stampato a Lione la data 1605, e del 1615 e’ la dedica acclusa quando il poeta si recò a Parigi: la regina era stata incoronata nel 1610.
A proposito dei ritratti del poeta de La Galeria, conclusivo studio e’ dato nel saggio di Jonathan Unglaub al suo serico ritratto del Detroit Institute of Art (fig.7), acquistato a Londra alla Christie’s nel 1888 e poi sul mercato statunitense, fra i ritratti di italiani insigni di Frans Pourbus, il pittore belga di una dinastia di ritrattisti che Marino aveva incontrato in periodi e luoghi diversi. Il dipinto era stato ritrovato e pubblicato nel 1959 da Pierre Rosenberg, dall’identificazione di un’incisione di Nicolas Briot (fig.6), incisore alla corte francese e coniatore della corona inglese. Dall’incisione di Briot, forse predisposta nel 1621 all’edizione parigina dell’Adone (1623), fu tratta anche l’illustrazione (fig.5), nuovamente in controparte, dell’elogio del poeta pubblicato dal Museum Historicum et physicum di Giovanni Imperiali, medico vicentino dello Studio padovano, discendente dal ramo genovese della famiglia, edito a Venezia nel 1640 da Giunta, che conferisce alle immagini dei suoi valent’uomini una rassomiglianza fisica e ne trae, al pari di Giovan Battista della Porta, una concordanza psicologica. La corrispondenza mariniana da Parigi a Lorenzo Scoto nel 1621 effettivamente illustrava un “ritrattino”, del quale Pourbus stesso avrebbe eseguito la matrice per l’incisione di Briot, e forse da includere alla redazione manoscritta, commentata da Scoto e da Fortuniano Sanvitale, dell’Adone edito a Venezia da Giacomo Sarzina nel 1623 - della quale Teodoro Correr conservava la trascrizione esemplare per l’edizione di Amsterdam del 1680 (Museo Correr, Venezia, ms. datato 1669-1680, Correr 51/2-54/5) - attestando come l’ovato piccolo (fig.5), passato da un editore veneziano all’altro, fosse in ottavo (Carminati 2010) e come, ancora una volta, l’epistolario di Marino fosse attendibile. Lo sarebbe anche Carlo Ridolfi se l'incisione fosse tolta dal Ritratto in età giovanile di Pietro Malombra, ed eseguito al suo esordio dal pittore, che diverrà ritrattista celebre al pari di Tiziano, ormai imbiancato il poeta giunto all'edizione de La Galeria.
Il testo di Unglaub illustra, tra le voci transalpine, i rapporti inoltre intrattenuti dal poeta con i pittori fiamminghi alla corte parigina della Reggente di Francia Maria dei Medici, ricordata pure ne La Galeria. In particolar modo dà un’esaustiva rassegna dell’affinità programmatica di quattro soggetti del Louvre, celebrativi degli avvenimenti biografici della sovrana, tra le ventiquattro tele dipinte da Pietro Paolo Rubens per la residenza reale del Palais du Luxembourg ed ispirate proprio dal panegirico de Il Tempio.
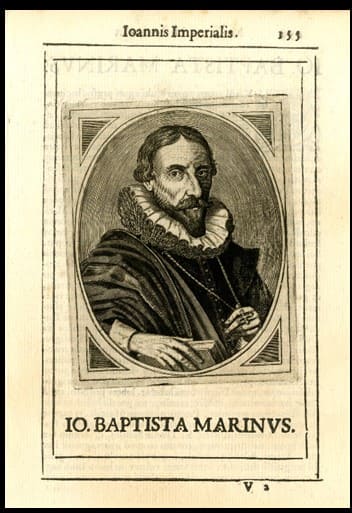

Fig. 5 - Incisione del ritratto di Giovan Battista Marino (tratta da: Giovanni Imperiali, Museum Historicum et Physicum, Venezia 1640, tv. 133)
Fig. 6 - Nicolas Briot, Ritratto di Giovan Battista Marino, incisione da Frans Pourbus (Bibliothèque Nationale, Parigi)
Ai capricci di statura europea delle stampe raccolte nell’esilio alla corte francese, e non solo, e’ avanzato il lavoro di Beatrice Tomei, dove viene maggiormente approfondita la scrittura mariniana sulla consistenza incisoria de La Galeria e gli spazi relativi che, oltre al bulino, l’acquaforte occupa nel poema, in prevalenza specificatamente precisata dall’autore.
Nella tela (fig.7) con l’ovato di Pourbus (Francesco Purbis ne La Galeria) - riprodotta in copertina nel volume recensito -, l'ovato ovviamente più piccolo del formato della tela, Marino indossa la croce di Cavaliere di San Maurizio, che non aveva ricevuto nel 1607, quando il pittore aveva soggiornato a Napoli per stimare la collezione di Matteo di Capua per i Gonzaga (Giuseppe Alonzo 2010). La fulva capigliatura che aveva avuto nella giovinezza, ramata in questo ritratto di Marino, lo denota stempiato e di mezza età e nello ‘status’ ufficiale di poeta della corte parigina. Episodio storico che non impedisce di riconoscere l’illustre accademico napoletano fuggiasco, comunque effigiato da Caravaggio nel pellegrino S. Giacomo Maggiore (fig.1). Ritenuto un S. Rocco (Mina Gregori, in Civiltà’ del Seicento a Napoli, 1984), dalla barba rossa, è individuato nella tela delle Sette Opere di Misericordia del 1606, di fronte al ritratto del pontefice Paolo V nei panni del sacerdote, con fascia e colletto pieghettato bianchi, e che rappresenta la missione di S. Pietro: la guida e l’ospitalità della chiesa ai fedeli, ai viandanti, ai bisognosi, ai pellegrini e fuoriusciti, simbolicamente un oste della chiesa. Caravaggio aveva conosciuto a Roma Marino ed anche se questi non fosse stato a Napoli proprio nel 1606, o non fosse pubblicamente comparso neanche a Roma, l’abitudine del poeta di farsi ritrarre in ogni passaggio della sua esistenza e di inviare negli spostamenti suoi ritratti per posta, specialmente cartacei, non esclude che ne circolassero a Napoli nel 1606.

Fig. 7 - Frans Pourbus, Ritratto di Giovan Battista Marino (Detroit Institute of Art, Detroit)
Del resto è nota la sua affermazione (Lettera 359): “Di me in Roma sono stati fatti mille ritratti, ma pochi hanno colpito.” Un ritratto di Marino di Caravaggio che, come riferirà Giovan Pietro Bellori, circolò nelle accademie più illustri, tra gli aderenti del Pio Monte, ad un oggettivo raffronto col più tardo di Pourbus, eseguito a Parigi, fu il capolavoro delle Sette Opere di Misericordia (fig.1). Ai piedi della grande tela caravaggesca nella chiesa del Pio Monte, che ebbe due fasi costruttive, dal 1607 al 1621 e nel 1659, è posta l’iscrizione lapidaria, con l’enunciazione delle opere caritatevoli, del breve istitutivo di Paolo V Borghese, trascritto anche nell’archivio storico del Monte, al quale pertiene il documento del donatore della pala Niccolò Radolovich: “...la città di Napoli deve ducati 1000 […] ricomprati dal nostro monte da Niccolò Radulovich” (ASPMM, Fondo Antico, Ld. 4, Registri di contabilità 1604-1605. fol. 55): la chinea in forma mutualistica concessa alla città per l’elezione del nuovo pontefice, che collega a questo dipinto la commissione di Radolovich al pittore e la relativa cedola bancaria di pagamento elargito e non, come e’ stato supposto, ad una pala perduta o alla Madonna del Rosario (Kunsthistorisches Museum, Vienna), pure a Napoli ed eseguita nel 1607 (Loredana Gazzara 2019, nota 63).
In effetti, il giudizio dei biografi mariniani di criminalità sofferta nella sua non lunga esistenza è anche maggiormente severo di quello tributato a Caravaggio nella sua breve vita da ribelle, che svia le circostanze della morte improvvisa priva di onoranze funebri, ma entrambi, negli innumerevoli, rispettivi encomi loro tributati, furono riscattati in vita dall’esilio e, soprattutto, dall’ammirazione durevole suscitata dalle loro opere.
E’ singolare che Marino nel “S. Pietro piangente di Niccòlo da Lorena”, Nicolas Cordier, che Baglione vorrà scultore della fontana di Galatea al Palazzo del cardinale Scipione Borghese sul Quirinale, accenni una pasquinata alla Tomba di Silvestro Aldobrandini e di Lesa Deti nella Cappella Aldobrandini di S. Maria sopra Minerva, genitori del pontefice Clemente VIII, stabilitisi a Roma. Per la cappella nel 1604 Cordier scolpì i due depositi funerari michelangioleschi, simili a due statue di fiumi. Soltanto l’anno seguente, morendo uno dopo l’altro il pontefice Aldobrandini e il Medici, Cordier divenne scultore del neoeletto papa Paolo V, che allontano’ da Roma il cardinale Pietro Aldobrandini e dal Vaticano definitivamente il cugino Cinzio, titolare di S. Pietro in Vincoli, dov’era il Mosé di Michelangelo, sostrato evenementale dell’iperbole di irremovibilità del pontefice: “E se ben fragil vetro,/ parvi agli assalti,/ Io son PIETRA in effetto,/ Poiche novo Mosé mi trahe da’ lumi duo vivi fiumi.”
Paolo V rifondò l’ordine di San Maurizio e Lazzaro, di cui il poeta stesso sarà insignito nel 1609, ma lui, ricordando dipinti di altri maestri nel formato del ritratto della sua persona in varie occasioni di celebrità e in età differenti, come Bartolomeo Schedoni, Giulio Maina, Pietro Malombra, Giovanni Contarini e Raffaello Rabbia, in un solo luogo de La Galeria avrebbe parlato di un ritratto di Caravaggio. Il pittore veneziano Giovanni Contarini e il piemontese Raffaello Rabbia non sono inclusi nell’elenco pubblicato da Carminati, che vide la luce nell’edizione delle Lettere del 1628: i due ritratti non sono noti, ma, inseriti ne La Galeria, dovevano appartenere alla collezione personale del poeta ed essere stati eseguiti ‘per procura’, e con profitto, dal ritrattino del Pourbus nel 1619: Rabbia, per inciso, deve proprio a Marino il fatto che la sua notorietà abbia varcato la soglia dell’Ottocento e Contarini parte della sua fortuna dall’essere rappresentato nella raccolta del marchese Vincenzo Giustiniani. In nessuna occasione Marino avra’ ricordato in prima persona la tela napoletana di Caravaggio per la quale prestò il suo volto a S. Giacomo, nel frangente memorabile del sonetto dedicato a S. Pietro, e che per lui stesso aveva avuto il peso di una condanna: l’allontanamento anche da Roma nel giugno del 1606. In incognito, la sua fama a Roma e a Napoli e quella del dipinto di Caravaggio erano di per se’ alle stelle. Anche Simon Vouet doveva conoscerlo quando ombreggiò il suo ritratto inciso di Marino.
Reni, secondo quanto riferito da Carlo Cesare Malvasia (Malvasia, Felsina pittrice, 1678, T.II, IV, p.10) lo ritrasse in riconoscenza dei versi emblematicamente dedicati da Marino alla sua “Callisto” ne La Galeria, ed è, percio’, solo desumibile che avesse ritratto il poeta al suo rientro da Parigi. Come è altrettanto possibile che Reni, attivo a Roma per il cardinale Aldobrandini nel 1605, con Ludovico Carracci avesse eseguito, insieme alle dorature degli stucchi, i due riquadri piccoli sulle pareti sopra i nicchioni delle statue nella parete lunga della Galleria Farnese, con le Storie di Callisto, su cartone di Annibale Carracci: la ninfa di Diana, scoperta incinta per l’inganno patito da Giove, vi viene mutata in orsa da Giunone e poi immortalata in cielo dal dio nella costellazione più brillante della luna. Reniano l’incantevole schiarimento dell’azzurro dal tramonto all’alba innocente cantato poeticamente: ancora un simbolo di redenzione dalla colpa nel naturalismo impercettibilmente cangiante di tono del cielo notturno, che ora vi si può solo indovinare.
Per comprendere la struttura del poema di Marino è indispensabile leggerne l’indice, che chiameremmo una ‘Tavola delle cose notabili’, se fosse stato un itinerario o una guida di città, ed è invece il ‘Racconto della Galeria’, quasi un omaggio al firmamento di favole dell’astronomo Igino, ma sempre accostato criticamente al museo storico comasco di Paolo Giovio e, nel panorama dell’esegesi mariniana qui presentato, limitato alla parte prima dell’opera: ‘Overo delle Pitture’, la più consistente.
A condizione che si faccia eccezione, incluso tra le Sculture, per il Capriccio della statua del ‘Vecchiarel Sileno’, ricordato nel capitolo di Emilio Russo, che fa centro sulle sincronie tra La Galeria e l’Adone. E che, forse più di ogni altro testo della collectanea presentata, acconsente ad evidenziare proprio i miti della Galleria Farnese, nel repechage, non sempre databile, dello Zibaldone di Marino, che, più di un diario di lavoro sulla poetica ovidiana, sottostava altrettanto alla Galeria. Domenichino avra’ dipinto La morte di Adone in altro ambiente del Palazzo Farnese, ed il Ganimede in un riquadro piccolo della volta della Galleria, narrando i due volti dell’apoteosi della natura umana. Ma è sul Ganimede di Lucilio Gentiloni, nel cantiere di Lelio Orsi a Novellara, che Marino sposta caricaturalmente l’introvabile Ritratto di Jacopo Bonfadio ‘benacensis’, padano, intimo di Paolo Manuzio e di Pietro Bembo, condannato al rogo per il reato di sodomia nel 1550.

Fig. 8 - Annibale Carracci, Sileno ebbro, acquaforte, Sottocoppa della Tazza Farnese (stampa da matrice d’argento del Museo del Real Bosco di Capodimonte, Napoli, Foto ICCD)
Inoltre, a proposito di eccessi solipsistici, per non dire sovrumani, ancora più sensibile sembra il nesso del Capriccio de La Galeria della “Statua del Sileno cadente” alla statua ‘parlante’ di Sileno della Fontana di via del Babuino, sistemata almeno dal 1576. Giovan Battista Cavalieri, nell’Antiquarium Statuarum Urbis Romae (edizione: Roma 1585, II, tav.82) aveva inciso nel giardino di Villa Medici una scultura distesa di Sileno: ‘Silenus In hortis Magni Ducis Etr.(uriae)’.
Annibale Carracci, che aveva dipinto Sileno a cavalcioni dell’asino nel Trionfo di Bacco e Arianna, incise anche la sua caduta (fig.8), ebbro di vino, nel sottocoppa d’argento della Tazza Farnese (Museo del Real Bosco di Capodimonte, Napoli; Museo Archeologico Nazionale, Napoli), avvalendosi di Francesco Villamena per la relativa acquaforte.
La Tazza Farnese antica, un vaso in pietra dura, recava sul retro la Testa della Gorgone e nel fondo Andromeda e Perseo che riceve da Plutone la fertile cornucopia, con la Sfinge che simboleggia ancora gli Inferi. De Ribera avra’ vantato a sua volta, vergata a mano sulla tela del Sileno ebbro del Museo del Real Bosco di Capodimonte, la sua ascendenza all’accademia romana.
Il poeta conosceva il fregio di ambientazione marina, dovuto al disegno di Agostino Carracci e saturo di creature pesciformi ad illustrare l’Oceano di Venere, di fronte al globo celeste di Aurora e Cefalo della Sala Farnese, decifrato anche sulla falsariga de Il Rapimento di Cefalo di Gabriello Chiabrera, messo in musica da Luigi Caccini nel 1600. Al pari dei grandi del Rinascimento attingeva al repertorio delle Metamorfosi ovidiane in tutta la sua opera, e non solo al tempo il piu’ diffuso che potesse conformare complessivamente anche l’argomento della Galleria Farnese, collazionando al campionario sterminato di quei soggetti opere mirabili di artisti molto spesso perdute e, su un piano sincretico, in parallelo ad argomenti biblici, di storia antica e di profili di contemporanei memorabili propriamente detti.
Ma e’ anche vero che nella Galleria Farnese il riquadro con Venere, Elena e Proteo, come quelli di Galatea frutto della collaborazione di Agostino ed Annibale, fosse stato dipinto a cavallo tra i due secoli, poiché e’ datato e preceda, quindi, altrettanto, l’elaborazione mariniana delle favole ovidiane, nelle quali (Metamorfosi, Libro XII, 4) vi e’ soltanto un’allusione alla “sposa rapita” da Paride, che nel soffitto della Galleria occupa anche un altro riquadro, in cui il giovane pastore e’ il prescelto al Giudizio, e al quale a sua volta Marino dedica un’immagine. L’innocenza della sposa bambina, prima fra tutte Elena, e’ il ‘monstrum’ dell’affresco, di una Margherita Aldobrandini appena tredicenne, al cospetto del vissuto amoroso di Ranuccio Farnese, più che trentenne, cui allude l’altro soggetto di Cefalo irretito, con l’affresco coerente di Pan e Diana, entrambi allegorici degli amori per volere degli dei: il matrimonio combinato per esigenze patrimoniali e dinastiche e di avvicinamento al casato del pontefice Aldobrandini. Nell’affresco con Venere nel corteo marino dei Carracci sono sostanziali le differenze dal mito di Glauco e Scilla, che pure viene associato tuttora all’iconografia del riquadro, poiché la ninfa non e’ rapita, e nemmeno raggiunta da Glauco nell’estesa narrazione di Ovidio del mito, ma, per la sua ripulsa (Libro XIII, 730) e’ mutata in mostro da Circe (Libro VII, 65; XIV, 50) e come tale era costantemente raffigurata anche dai pittori barocchi. Ne’ l’ideazione di Agostino del riquadro della Farnese, che si era avvalsa dell’interpretazione di Fulvio Orsini, potrebbe esserne tanto discordante, se non fosse che e’ dissimulata da un argomento omerico posteriore a Ovidio e che presume anche una terza fonte, la Palinodia di Stesicoro, in cui, per volere di Venere, una falsa Elena e’ rapita per mano di un dio, che anche nell’affresco assume le sembianze di Proteo tra i Tritoni: Stesicoro è la vena letteraria della licenza poetica della Farnese, volta ad illustrare il passo celebre delle Metamorfosi del corteo di Proteo con le Nereidi e i Tritoni scolpito sulla porta bronzea del Tempio di Apollo. Perfino La Montagna Circea scritta da Melchiorre Zoppio in occasione del passaggio a Bologna della Duchessa di Parma Margherita Aldobrandini verte sulla nebulosa materia dell’invocazione di Venere sullo scoglio di Proteo per ottenere dal suo custode la sposa rapita promessa a Paride, operetta pur sempre immersa in evocazioni geografiche. Sullo Zoppio, Gerolamo Preti e Cesare Rinaldi, ritratto dall’incisione di Agostino delle Rime di Cesare Rinaldi del 1590 e molti altri accademici bolognesi e’ difatti imperniato l’ultimo lavoro del nostro volume a cura di Giulia Iseppi e Raffaella Morselli. Alla duplice natura che incarna la bellezza effimera, paragonabile alla candida nuvola di un cigno, allude anche l’”Helena” di Marino tra i Ritratti de La Galeria: “Helena. Augel di bianche penne/ In un parto con Castore, e Polluce/ Mi produsse ala luce./ Penna poi non men candida, e gentile/ Scrisse le mie fortune in chiaro stile./ E ben certo convenne,/ Che come fui da un Cigno generata,/ Così da un Cigno ancor fossi cantata. La medesima. DELA volubil mia/ Leggerezza incostante,/ ch’habbia il letto schernito/ Del pregiato marito e che mi sia/ Data in balia d’un peregrino amante,/ Non sia chi mi ripigli,/ Ne’ chi si meravigli,/ Pero’ ch’esser non deve/ La figlia d’un augello altro che lieve.” L’estasi stessa del rapimento poetico, figlia del piu’ divino amante, la leggerezza dell’ovidiano “materiam superabat opus” nell’ineffabile idea caraccesca. La suggestione mostruosa della Scilla ovidiana appartiene d’altra parte allo stesso repertorio di Marino, nelle Rime Marittime, lette nell’edizione di Ciotti del 1620 della Lira, che ristampa la dedica a Melchiorre Crescenzi, in cui e’ raffinato interprete della vaghezza delle frammentarie Immagini di Filostrato, che includevano anche l’idillio del Ciclope. Inafferrabile perfino da Proteo e’ la Lilla amata dal pescatore Fileno, in cui il poeta s’immedesima, paragonandola, nella genuina favola di Siringa, all’orca in cui fu Scilla mutata da Circe (La Lira, Venezia 1620, p. 53): “O piu’ che Scilla, e che Cariddi ingorda,/ Orca, mostro maggior del nostro faro,/ Piu’ che mar, piu’ che scoglio, iniqua e sorda.” Ad una scultura di “Protheo”, la scimmia della natura, la scimmia del mare, il “pescihuomo” trovato sulla riva del Rio della Plata, o “il cavalier marino” nel sarcasmo di Tommaso Stigliani nel Mondo Nuovo edito nel 1617, il dio veggente capace di trasformarsi, “divenuto di sasso” recependo la provocazione di Stigliani, è dedicata ne La Galeria una breve, lapidaria, composizione dal poeta più che risentito, affondo di polemica ed invettiva reciproca. Era il trionfo marino di Proteo della Galleria Farnese, scolpito sull’ovidiana porta bronzea apollinea, il ‘thiasos’ frequente nei sarcofagi, culmine del rapimento estatico dell’idea, il plagio che entrambi i poeti erano soliti rinfacciarsi l’un l’altro nella mutevolezza idolatra della fama.
Anche fuori di metafora la mollezza languida della nuda Elena resa immortale dai Carracci, trofeo afferrato da Proteo nel coro marittimo di Doride, dove risiede l’imperio di Venere, potrà apparire indifferente e inconsistente o ideale e astratta, ma non ha niente a che vedere con un mostro, né con la roccia, ne’, per essere Faone di Lesbo, giace su uno scoglio, o, per essere Teti, l’immutabile Peleo potrebbe trasformarsi al suo fianco come il divino Proteo. Della complessa mitografia di Venere nel coro di Nereidi, che pero’ e’ accovacciata nell’affresco e mostra il fianco (Venere Farnese, MANN), e Paride raffigurato sulla parete corta, con Atena ed Hera nel bagno di verginità del trio del giudizio, dai tipi delle statue Farnese, oppure Galatea, oscillata dal titolo di incisioni edite oltre la metà del secolo, Bellori darà nell’Argomento della Galleria una sintesi di erotismo edificante. Dall’etica degli affetti sempre più improntata al costumato senso del decoro della commedia L’Anchora (1598) di Giulio Cesare Torelli, un altro giurista intimo amico di Marino: i "contrari affetti" della tragedia La Galatea dell'Innominato Pomponio Torelli, edita a Parma nel 1603 con dedica al cardinale Odoardo Farnese, in cui altrettanto compare il Coro di Nereidi sorelle, contrapposto dialogico della ninfa Galatea rappresentata nella Galleria nei due riquadri verticali. Era dovuta a Giovanni Baglione la rilettura del quadro riportato come di Galatea, che riteneva interamente di Agostino Carracci, nell'edizione delle Vite del 1642 e ancora oscillato a Venere da Bellori.
Non c’è dubbio che Agostino nella prima redazione del quadro riportato del cartone alla National Gallery di Londra ridisegnasse il Tritone con la buccina, a lato di Proteo, dalla Galatea di Raffaello, che fu variato poi da Annibale, presentandolo di tergo nel suo disegno e nell’affresco, tra loro una collaborazione esemplare. Né che Venere sia seduta e non in piedi come Callipigia sulla groppa di un delfino.
Se Vasari e Ripa erano più che noti a Marino, non lo erano probabilmente gli Het Schilder boek o Libro della pittura di Karel van Mander, usciti nel 1604 ad Amsterdam, ma il pittore belga vi afferma di essersi intrattenuto nei cantieri dei Carracci della Farnese e del Cavalier D’Arpino di S. Lorenzo in Damaso a Palazzo della Cancelleria, come ha fatto notare Pasquale Sabbatino nel saggio ‘‘La Galeria del Marino e la Galleria Farnese raccontata da Bellori” (2016-2018). E’ possibile supporre altrettanto del manoscritto dell’aretino Scipione Francucci della ‘Galleria dell’Ill.mo e Rev.mo Signor Scipione Borghese’, un’altra galleria in formazione sullo scorcio del Seicento, il Borghesiano 184 della Biblioteca Vaticana datato 1613, oggi in DigitVatLib, l’edizione digitale vaticana. Il manoscritto illustra in versi la Galleria Borghese e costituisce il precedente del genere letterario che tanto Giovan Battista Marino, quanto Giulio Cesare Gigli con La Pittura trionfante, edita nel 1615, porteranno alla gloria delle stampe. Era la precoce testimonianza di Van Mander, per quanto contraddittoria, a parlare del dipinto di un David e della testa di un gigante di Caravaggio sul cantiere D’Arpino di S. Lorenzo in Damaso a Roma, colorando l’episodio sulla sproporzione di David e Golia nel ‘leit motiv’ sulla somiglianza caricaturale dei ritratti, in cui Caravaggio si sarebbe fatto beffe del maestro. ‘Topos’ ripercorso dalle fonti successive, che a proposito proprio del dipinto Borghese giungeranno infine a scoprire nella piccola testa di Golia non altri che l’autoritratto di Caravaggio e nel David quello di un suo pupillo, o di un pupillo di Giovanni Baglione, Tommaso Salini. Anche Mancini riferiva l’episodio di un diverbio con il Cavalier d’Arpino, situandolo in prossimità del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, dove questi affrescava - a Napoli, alla Certosa di S. Martino nel primo quarto dell’ultimo decennio del Cinquecento - la Sala degli Orazi e Curiazi, vicino all’Ospedale di S. Maria della Consolazione e nei pressi della chiesa di S. Lorenzino alla Torretta, inglobata dal Convento di S. Ambrogio, fra l’‘insula’ dei Mattei e la Torre dei Crescenzi.
Il tramite del sacerdote Ferrante Carli Gianfattori da Parma, in virtù della sua difesa di Marino nel 1614 e della corrispondenza da entrambi intrattenuta con Ludovico Carracci, ripropone sempre la prossimità dei due intellettuali alla committenza dei duchi di Parma: Carli, al servizio del cardinale Paolo Emilio Sfondrati, titolare della Basilica di Santa Cecilia, per la quale lavorarono tanto Francesco Vanni quanto Giovanni Baglione, era tornato a Roma quasi indigente nel 1618 e solo allora divenne segretario di Scipione Borghese. A proposito dello spunto di ricerca sul mecenatismo Farnese, Marco Tanzi ha avanzato da decenni il ritrovamento in una collezione privata di Buenos Aires della grande tela del Giudizio di Mida di Giovan Battista Trotti detto il Molosso (fig.9), puntualmente dettagliata da Marino nella favola “Il Giudicio di Mida del Malosso”, la cui fama aveva raggiunto anche Giulio Cesare Gigli.

Fig. 9 - Giovan Battista Trotti detto il Malosso, attr.,Giudizio di Mida (Buenos Aires, collezione privata)
Anche elencato per aver favorito Marino era il lucchese Paolo Guidotti Borghese, rifondatore dell’Accademia di S. Luca, che nel 1608 esegui’ un David e Golia per la Basilica di S. Paolo fuori le Mura (Pinacoteca della Basilica di S. Paolo fuori le mura), ribaltando, a memoria. da destra a sinistra il soggetto di Caravaggio ricordato anche da Van Mander. Marino memora Guidotti per il gruppo scultoreo a sei figure “d’un pezzo” che esegui’ per il pontefice Paolo V Borghese nel 1608, che sarà descritto anche da Giovanni Baglione, e, sempre ne La Galeria, per un’incisione su rame del ritratto di Scipione Borghese nel Capriccio (p. 318), che contiene la fin troppo esplicita, sgomenta allusione alla posizione legittima del cardinale nella compagine ecclesiastica: “Pargoleggia il consiglio, a cui comparte/ PAOLO, di Pier le sacre chiavi, e il regno.”
Com’era inevitabile, molti degli artisti nell’epicentro di Marino erano più che rappresentati nella Galleria Borghese, tra cui Antonio Tempesta, che nel 1599 aveva dedicato al pittore aretino Teofilo Torri la serie incisoria di Scene di Battaglie Lambertini (Gabinetto delle Stampe, Pinacoteca di Bologna). Tempesta dipinse su pietra per il cardinale Scipione la Vocazione di Pietro con la Nave degli Apostoli sul Lago Tiberiade e su tela due soggetti di cavalieri che si destreggiano in scene di Caccia. Ed è tuttora anonimo nella Galleria Borghese il piccolo rame di Semiramide di Maarten van Heemskerk (fig.10), inciso a suo nome nella serie di Philip Galle (fig.11) e con la torre spiraliforme di Babele, da sempre ignorata la regina che Marino analogamente ritrarrà davanti le mura di Babilonia ne La Galeria (p. 285), appartenente alla raccolta di Scipione: “La medesima [n.d.r.: Semiramide]. Colei, che di tal fabrica si pregia;/ Fu miracol di pompa e di splendore/ Del muro di Babel la mole egregia./ Ma miracol fù ben molto maggiore/ Non tanto già di gloria, e di valore/ e di grandezza generosa, e regia/ Quanto d’ingratitudine ferina,/ Che diè la morte a chi la fè Reina”, che fa propria un’immagine

Fig. 10 - Maarten van Heemskerk, Semiramide (Galleria Borghese)

Fig. 11 - Maarten van Heemskerk, Philip Galle, Babylonis Muri (incisione controfondata, foto ICCD)
illustre nella galleria del cardinale. Nella chiesa di S. Stefano Rotondo, sopra la porta della sacrestia, Tempesta aveva dipinto ancora la Strage degli Innocenti, presente anche a Guido Reni (1611) nell’omonimo suo dipinto alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, argomento cui Marino avrà dedicato l’operetta intera, dallo stesso titolo e pubblicata postuma, della quale ancora Caruso ha ritrovato il manoscritto. Nel madrigale della “Strage de’ fanciulli innocenti” della Galeria (p. 58) Marino, successivamente alla redazione manoscritta, sostituirà il nome di Guido Reni a quello di Giovan Battista Paggi. Anche il genovese Giovan Battista Paggi, infatti, aveva dipinto nel 1606 (Soprani Ratti 1768, I, p.133 [1674]) una Strage degli innocenti, opera perduta, della quale è pubblicata una fotografia del secolo scorso, e che è solo frammentaria nel ricchissimo ‘cahier’ di questo instancabile disegnatore, protagonista di sfortunate vicende che lo spinsero all’esilio in Toscana, ma che Marino potè conoscere negli anni torinesi. Difficile resistere alla suggestione di calzare sullo splendido ‘noir’ del Sansone e Dalila di Palazzo Bianco a Genova (fig.12) il sonetto sul tema esemplarmente assegnatogli da La Galeria, tema iconografico finora distratto dal catalogo del pittore e che Marino aveva potuto ammirare prima di recarsi a Parigi. Il soggetto fu replicato dal seguace di Paggi, Domenico Fiasella, nel dipinto del Louvre, un’altra testimonianza dell’interesse da lui suscitato al di fuori dell’ambito fiorentino in cui si era affermato.

Fig. 12 - Giovan Battista Paggi, attr., Sansone e Dalila (Palazzo Bianco, Genova)
Lo stesso congeniale Tempesta aveva disegnato una serie incisoria del ‘Metamorphoseon’ ovidiano, edita da Pieter de Jode di Anversa nel 1606. Solo nel 1621 Marino ottenne personalmente “Il Goffredo ovvero Gerusalemme Liberata” incisa da Tempesta e stampata a Roma da Giovanni Angelo Ruffinelli nel 1607.
Ancora un altro dipinto de La Galeria “L’Ecce homo del Cavalier Baglioni” (fig.13) con il dettaglio della fune, strumento di tortura eloquente, anche se solo pensato in rapporto al ruolo inquisitorio del cardinale Scipione nei processi al poeta, non potrebbe smentirlo sempre aggiornato sull’accrescersi della Galleria Borghese (Carminati 2008; 2018), non meno che sul mecenatismo Farnese. Né ci sarebbe ragione di dubitare che il Virgilio del poeta nel suo viaggio romano fosse stato dagli anni napoletani proprio l’artista con la bottega di maggior successo, Giuseppe Cesari D’Arpino.

Fig.13 - Giovanni Baglione, Ecce homo (Galleria Borghese, Roma)
Del filo conduttore del favore ricevuto dal Cavalier Baglione ancora negli anni successivi al servizio prestato da Marino al cardinale Pietro Aldobrandini, potrebbe essere testimonianza la tela di Filomela e Procne dei Musei Civici di Carpi (fig.14) un quadro riferito a Mattia Preti in forza del soggetto sanguinario (ripristino 1998), che però non trova rispondenza alcuna nel catalogo delle sue opere nella biografia dedicatagli da Bernardo De Dominici. Viceversa, a documentare l’opera prestata nel corso degli anni al duca di Mantova Ferdinando Gonzaga, e a molti altri potentati politicamente limitrofi, che Marino potè conoscere nella permanenza savoiarda, c’è la memoria autobiografica di Giovanni Baglione.
Inoltre, sempre a proposito della committenza Farnese, il monocromo medaglione della Galleria Farnese con Salmace ed Ermafrodito, avvinti l’uno all’altra, molto ridipinto, vorrebbe che fosse Marino partecipe dell’ideazione con Ludovico Carracci nelle ultime realizzazioni degli affreschi della Farnese e che per se stesso, che ne era stato testimone, gliene richiedesse per posta una copia.

Fig. 14 - Giovanni Baglione, attr., Filomela e Procne (Museo Pio, Carpi, Modena)
In una tela (cm.92,5x119) di ambito emiliano, appena pubblicata da Finarte Minerva Auctions, sullo specchio d’acqua compare un esterrefatto Ermafrodito (fig.15), che nella posa statuaria resiste allo slancio di Salmace: “...Ma non si sa, qual perde, o qual avanza,/ Il miracol d’Amore,/ O’ quel delo stupore,/ Quello in un corpo sol congiunse dui/ Questo divide da se stesso altrui”: una coincidenza espressiva che di per se stessa non è che una conferma che del dipinto di Ludovico nel medaglione monocromo della Galleria Farnese dallo stesso soggetto esemplare, sia davvero esistito almeno un pittore carraccesco che condividesse e trasferisse nel segno l’evidenza datane da Marino.

Fig.15 - Ludovico Carracci (?), Salmace ed Ermafrodito (Lotto Finarte 2021)
Nel 1613 il ‘David con il teschio di Golia’ di Caravaggio era nella Galleria del cardinale Scipione Borghese, dove ancora si trovava nel 1650, cioe’ dov’è oggi, e il fatto che fosse appartenuto al conte di Villamediana, il poeta Juan de Tassis y Peralta, e’ una notizia di Giovan Pietro Bellori, che non ignorava, nell’ultima redazione della Vita di Caravaggio data alle stampe nel 1672, la Villa Borghese Fuori di Porta Pinciana descritta da Iacopo Manilli, edita a Roma nel 1650, e quale fosse il Davide e Golia dipinto da Caravaggio. Un tema questo altrimenti affrontato in dettaglio da Maria Cristina Terzaghi, ma senza che il biblico Re David salmodiante del Ritratto (pag. 84 ediz.1620) dell’inno mariniano che così s’intitola, declamazione rarissima anche alla fine del Cinquecento, priva di ogni altra generica indicazione se non il pentimento del profeta di aver usurpato il regno di Abigail, possa sovrapporsi finora a nient’altro che al vecchio Re David dipinto da Bartolomeo Passarotti alla Galleria Spada di Roma (fig.16). Un quadro con nessun altro intento biografico ed esornativo che quello di un’immagine sacra di una cappella di famiglia, nella raccolta formata dal cardinale Bernardino Spada, che in parte proveniva dalla Villa Spada di Brisighella nella provincia di Ravenna e di un pittore, anche per questo, sempre segnalato ai vertici della pittura nei rispettivi indici tanto da Marino che da Gigli. Al “David, ch’uccide Golia” nella villa del cardinale Aldobrandini di Frascati (fig.17) affrescato da Giuseppe Cesari D’Arpino nel 1602 e’ dedicata invece dal poeta la sua Historia epica (pag. 50 ed. 1620), subito seguita dal noto David con la testa di Golia di Guido Reni del Louvre, esemplare del resto non unico del maestro, eseguito a figura intera e in scala a contrappunto armonico antitetico al dipinto di Caravaggio, e preceduta ne La Galeria dalla storia delittuosa di Cesari con Giaele ucciso da Sisara nel sonno nella stessa villa.

Fig. 16 - Bartolomeo Passarotti, Re David (Galleria Spada, Roma)

Fig. 17 - Giuseppe Cesari D’Arpino, David che uccide Golia (Villa Aldobrandini. Frascati)
Non sappiamo da altre fonti se Peralta avesse avuto o meno nel primo decennio del secolo il David di Caravaggio, acquistato o ricevuto in dono da un accademico romano o da un membro della sua famiglia residente a Roma: pur conoscendo la Galleria di Scipione Borghese, Marino, al contrario di Reni, non dimostra affatto di avervelo veduto. Il documento dell’Archivio del Banco dello Spirito Santo di Napoli (ABSN, Giornale copia-polizze 5 novembre 1610), più volte pubblicato da Vincenzo Pacelli, per il quale il David di Caravaggio fu fatto copiare a Napoli due volte da Baldassarre Aloisi detto il Galanino, non smentisce che il quadro fosse di proprietà di Juan de Tassis y Peralta e che almeno una delle copie ordinate dovesse arredarvi il palazzo vicereale di Pedro Fernàndez de Castro, conte di Lemos (Anna Coliva 2010) e l'altra fosse destinata all'Arciduca d'Austria, visto che Ottavio Costa ne aveva acquisito una copia da Ludovico de Tapia nel 1607 (Maria Cristina Terzaghi 2007, p.408), un quadro con il 'ritratto di re David' nell'inventario testamentale di Ottavio del 1639.
L’insistenza di tutti gli apparati del nostro volume sulla ‘poiesis’ mariniana de La Galeria, la discosta significativamente, anche se nello stile pervasa dalla satira di Pietro Aretino, dallo sguardo innegabilmente sporto dal poeta sulle altre operette iconografiche nel medesimo scorcio cronologico, come egli stesso avvertiva. Convincendoci ancora di più che sia sottostante alle sue riflessioni una vera e propria epopea del gusto artistico fra Cinque e Seicento, ma imperniata sugli altrettanti cammei autobiografici, già storici, a suo dire, nell’autentica ecfrasi barocca della prosa e della poesia greco-latina, incastonata di quadri della Galleria Farnese. La Farnese era il romanzo delle Metamorfosi ovidiane, compresa l’epica omerica, e dove certo non venivano a mancare citazioni esplicite del beneamato Virgilio. Sulla scrittura ecfrastica meno commentata de La Galeria tra le altre opere penetra la sua lettura, nel volume dedicato a Marino, anche Andrea Torre.
Gli autori di iconologie altrettanto memorabili hanno completato, almeno dagli studi della metà del secolo scorso, il registro metaforico e allegorico dei biografi d’arte che conobbero non solo la Galleria Farnese dei Carracci e le opere di Caravaggio, ma che ebbero occasione di incontrare gli uni e l’altro personalmente, come Giovanni Baglione, e che, se si volesse aggiungere all’elenco di scrittori e poeti anche l’antagonista di fatto di Marino, Gaspare Murtola, che nel 1603 dedicò alcune Rime ad opere caravaggesche, conobbero anche il poeta della Galeria. Finendo per svelarci un angolo della più accesa rivalità letteraria a cavallo del secolo e a quale proposito fosse inizialmente insorta tra i due poeti, poiché entrambi, contemporaneamente alle stampe, avranno trasfuso in versi la Medusa di Caravaggio. Né vi è altra cupidigia artistica, nemmeno nel dovizioso itinerario delle Considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini, anche condiviso da Marino nello spettro d’immagini di ‘ingordigia’ romana, sul quale si sofferma soprattutto Claudia Tarallo, che smentisca la notizia che fino al settembre del 1598 la famosa rotella dello scudo di Medusa si fosse trovata presso il cardinale Francesco Maria Del Monte, dove Caravaggio abitava, copia in antico di un’allegoria neanche menzionata a Roma da Gaspare Celio: un ‘ut pictura poësis’, uno specchio, nel quale nemmeno è possibile dubitare che l’autentico precedente del poema mariniano fossero le ‘poesie’ tizianesche, dipinte da Tiziano Vecellio ‘ante litteram’ del concettismo mariniano, e a questa antesignana intrusione ha dedicato le sue pagine, nel volume recensito, Andrea Zezza.
Non c’è alcun indizio, nel pur cospicuo apparato iconologico del libro, di quale fosse, la Medusa di Caravaggio a contrappunto nelle Favole de La Galeria, l’episodio del “Perseo che uccide Medusa di Giovanni Lanfranco”. Nel soffitto dell’appartamento al piano terra di Scipione Borghese nel Palazzo Pallavicini Rospigliosi c’è un ottagono centrale di Perseo che indossa i calzari alati e innalza la testa troncata di Medusa (fig.18), con le serpi che sfuggono in alto il suo stesso sguardo pietrificante e le gocce di sangue che colano ai piedi dell’eroe (da cui si formo’ Pegaso), tra gli sfondati di Giovanni da San Giovanni (Mina Gregori 1964), se non altro una testimonianza attinente la fantasia mariniana del Lanfranco: “… dove l’istesse vipere serpendo/ Dinanzi al fiero ciglio/ Fuggon per non vestir marmoree spoglie.” L’invenzione del titolo di Marino fu contesa dal soggetto di Luca Giordano nel Perseo e Medusa del conte d’Avalos, acquisto recente (2003) del Museo di Capodimonte a Napoli, attingendo, se non a Lanfranco, che gli fu maestro, al repertorio, dimostrando come sia esiguo fino ad oggi l’affidamento storiografico alla testimonianza della lirica di Marino, anche dove dettagliata. L’aspetto bifronte dell’‘ut pictura poësis’ oraziano che il poeta aveva enunciato nella chiosa del madrigale del Suonatore di liuto (Hermitage, San Pietroburgo): “...scriverem, canteremo, et egli et io”, figurava nell’immagine del verso lo spartito nel dipinto, che si trova davanti alla sua mezza figura. Nel madrigale, compreso nei Ritratti, del quale, a cura di Carlo Caruso, è illustrato nel testo il manoscritto nella redazione testimone (Biblioteca Reale di Torino, ms. Varia 288.15, c.18r; Adriano Colombo 1993) - comprensivo dell’intestazione: “A Michelangelo da Caravaggio Nel ritratto di se stesso” - lo scrittore s’immedesimava fino a rivendicare la paternità della canzone ‘Calthus’, che e’ designata nel quadro anche con un fiore, la Viola, il titolo del cantato dello spartito ‘Voi sapete che’ nel pentagramma, ma inoltre dell’idealizzato cantante, voce angelica solista: il paesaggista Giovan Battista Viola fra i pittori carracceschi a Roma era versato allo strambotto in musica (Carlo Cesare Malvasia). La sensibile differenza del titolo del madrigale mariniano nella stampa Ciotti, quasi corrotto nelle altre edizioni coeve, recitava: “Sopra il proprio ritratto dell’Autore di mano di Michelangelo da Caravaggio”, sollecitando il rilievo che il quadro non fosse un autoritratto o solo un ritratto ideale di Marino stesso, e la poesia non fosse un epitaffio, che Marino aveva altrimenti composto per Caravaggio, e a sua volta incluso ne La Galeria: “In morte di Michelagnolo da Caravaggio” (p. 235), ma un busto immortale di Amore, al cui ossimoro “Angel non già, ma dio”, presago dell’immortalità della fama nell’ombra, affidava la sinergia conviviale di un’interpretazione artistica del divino Caravaggio, “fecitor più che pittore” anche ne L’Adone (VI, 55). Il Suonatore di liuto nel 1607 si trovava nello studio del Cavalier d’Arpino, e nel 1608, prima di raggiungere la collezione Del Monte nel suo Casino di Ripetta, nell’appartamento di Scipione Borghese al Quirinale, dove sembra fossero di casa tra i suoi familiari anche i ‘protégés’, tra i quali il giurista canonico Cesare Gherardi.

Fig. 18 - Giovanni Lanfranco, Perseo con la testa di Medusa (Palazzo Pallavicini Rospigliosi, affresco della volta)
E’ più che verosimile che il madrigale, ora confrontato allo Zibaldone di Marino, come il dipinto della Viola o del Liuto di Caravaggio - il “Lauto” avrebbe storpiato Baglione, distinguendolo da una S. Cecilia e dimostrando come fosse stato un quadro noto negli ambienti romani, anche a dire di Gaspare Celio, di un giovane o “un putto che sonava il leuto” - fosse stato composto ancora nel Cinquecento e fosse rimasto nello studio D’Arpino, e vi fosse, per dirlo con le parole di Marino, raffigurato “un altro me stesso”: l’immedesimazione di un attore l’idea stessa della somiglianza. Gaspare Celio lo ricordava ancora nell’edizione della Memoria delli nomi dell’artefici (p. 134) del 1638, con dedica del 1620 a Giovan o Gian Vittorio De Rossi (pseudonimo Iano Nicio Eritreo), chiamando stavolta il giovane cantante il pastore frigio Paride di Michelangelo da Caravaggio nel Palazzo Mattei, dove aveva affrescato una sala con Il passaggio del mar Rosso nel 1606, e dove continuò a lavorare all’affresco della Caduta dei giganti fino al 1608 e per il quale riceverà successive commissioni fino al 1616. Anche De Rossi avrà dedicato nel 1643 nella sua ‘Pinacotheca’ di uomini illustri un profilo a Marino (p. 34). Certo è che nel 1626 tanto il S. Giovanni Battista Capitolino, documentatamente pervenutovi per dono dalla raccolta Mattei nel 1621, quanto il Suonatore di liuto di Caravaggio avranno fatto parte della collezione del cardinale Francesco Maria Del Monte, che, anche a dire di Raffaello Soprani lo aveva favorito, e che nel 1638 il secondo dei due era stato acquistato dal marchese Vincenzo Giustiniani, ma che solo il Ragazzo morso dal ramarro (National Gallery, Londra) era ricordato anche dalla biografia di Caravaggio di Joachim von Sandrart. Non c’è dubbio che Caravaggio nel 1606 avesse eseguito da tempo repliche autografe dei suoi soggetti più famosi, come il Bacco agli Uffizi ritrovatovi nel 1916, il S. Giovannino ad Ottavio Costa a Conscente nel 1624, e forse S. Giovanni Battista nel deserto anche il sincretico Narciso alla fonte nella relata di esportazione del 1645 a Conscente (Marco Pupillo 2010), che fu ritrovato nel 1913 in collezione privata milanese (Roberto Longhi 1968), la Buona Ventura ad Alessandro Vittrice, pervenuta alla Galleria Doria Pamphilj e donata al Louvre nel 1665 (Chantelou de Fréart), e che almeno una delle due versioni del cosiddetto Ragazzo morso dal ramarro (fig.19), si trovasse nello studio D’Arpino, dove fu confiscata nel 1607. La vera difficoltà è nel poter dire quale fosse stato il percorso collezionistico di ciascuna versione con notazioni storico-inventariali generiche del soggetto: è con beneficio d’inventario che può dirsi che tanto il S. Giovannino quanto la Buona Ventura Del Monte (Musei Capitolini, Roma) confluissero nel 1628 nella collezione Pio di Savoia. Anche quest’ultimo un dipinto che, nel sincretismo di un doppio ritratto d’artista, il giovane drammaturgo Giulio Strozzi e Fillide Melandroni, che avevano messo in scena un’aria da una famosa egloga di Fillide (dovuta forse ad Aurelio Orsi) - la Filli protagonista anche per Marino del bacio rubato alla promessa -, concepito con I Bari (Kimbell Art Museum, Fort Worth), attualizzava in due quadri la Parabola del figlio prodigo. La stratificazione di significati del messaggio cristiano rese noto il dipinto col nome da canzoniere dilettantesco di Zingara, come riportato da Giulio Mancini, non senza una volgarizzazione del racconto di Anania e Saffira dagli Atti degli Apostoli, che anche Masaccio aveva dipinto giovani nella Cappella Brancacci. Dopo la fuga del pittore a Napoli emerge la tendenza fra i suoi committenti romani ad accaparrarsi le sue opere senza discrezione, mossa tanto dalla curiosità ideologica quanto suscitata dalla commozione. Lo scenario che si ripeterà tra Roma e Napoli dopo la sua morte si era manifestato nella privatezza e nell’ombra della clandestinità negli ultimi anni romani. La recentissima edizione della Vita di Caravaggio scritta da Gaspare Celio nel manoscritto delle sue Vite degli artisti[1] ha messo nuovamente in luce lo stretto rapporto tra Celio e l’umanista Giovan Vittorio De Rossi nella stesura della Memoria delli nomi dell’artefici, opera che nel 1638 giunse alle stampe solo parzialmente, ma con la medesima impostazione accademica del manoscritto delle Vite (termine post quem non di quest’ultimo: 1616), noto al De Rossi. Al pari di Baglione, che dimostra di aver letto la Memoria (p.381), Celio in queste Vite affermava, morto Caravaggio, che molti suoi quadri non erano stati commissionati, ma venduti tramite Prospero Orsi, che li aveva copiati e ne aveva replicato il soggetto presso il Cavalier D’Arpino, dove era stato di casa. Probabilmente sua la copia di Antonio Barberini anche detta da Bellori "una donna in camicia", il soggetto ancora in bilico con una S. Cecilia. E’ proprio a Marino che si deve per esteso il corretto nome di Aurelio Orsi (m. ca. 1591), fratello, o per altri zio di Prospero, ma comunque personalità distinta da Lelio Orsi di Novellara, e che egli colloca tra i Ritratti dei poeti in lingua latina (“Aurelio Orsi, Fu scarpel la mia penna” p. 212). Forse la citazione non è abbastanza per dedurne un debito immediato de La Galeria all’operetta manoscritta nella struttura ecfrastica, intitolata Caprarola (BAV) e dedicata alla Villa di Caprarola di Alessandro Farnese. Ma è possibile che Celio nei due testi si riferisse ad uno stesso dipinto, ormai pervenuto a sua insaputa alla collezione Giustiniani, finalmente chiamando, in risposta al dio Giano rievocato da Marino, solo nella Memoria a stampa “Quella [n.d.r.: pittura] del Pastor Friso, ad olio, di Michelangelo da Caravaggio”, proprio il “Putto che sonava il leuto” dei suoi inediti, che aveva potuto copiare esposto a Palazzo Mattei, finalmente cogliendovi, con il consiglio di De Rossi, l’aspetto bucolico e angelicato dell'amante divino. Nella tela era la più famosa caraffa con i fiori di Caravaggio e i pochi frutti che anche Guercino potè ammirare ancora nella raccolta Del Monte, probabilmente, se non in precedenza, appena ingaggiato per dipingere l’Aurora nel Casino del Monte acquistato nel 1621 dal pontefice Ludovisi, a dire ancora, sempre nei manoscritti inediti, di Carlo Cesare Malvasia (Giacomo Berra 2016). Nel passo manoscritto di Malvasia traspariva più che altro come Guercino avesse lavorato nel Casino Del Monte alla morte di Caravaggio, ritraendosi nello strabico Plutone del Camerino, e dando corpo alle testimonianze di altri autori sul rifiuto del maestro vivente, e bandito, di avvalersi del suo operato, così come di quello di altri pittori, nelle piu’ importanti commissioni di quegli anni. Ed era Giovanni Baglione ad attingere tanto dalle opere di Gaspare Celio quanto a La Galeria di Marino e ad avvalersi dei manoscritti di Giulio Mancini e di Scipione Francucci.
I versi di Marino testimoniano che fosse il sublime la mira della bellezza dei quadri di Caravaggio ne La Galeria, il silenzio rotto dal suono che esprime anche il ‘pendant’ del Concerto di Caravaggio al Metropolitan Museum of Art di New York, alla metà del Settecento pervenuto agli Aldobrandini dalla collezione Barberini, dov'era inventariato dal 1631: gli uni e gli altri molto piu’ che un antidoto musicale al mal d’amore, come voleva parafrasare Walter Friedlaender nei Caravaggio Studies (1955), ancora oggi fondamentali per gli studiosi di arte, ma estasi visionaria della musica da camera, la forma privata dell'esultanza liturgica. La sincronia delle composizioni e’ evocata nel ‘leit motiv’ dello scherzo sinfonico dei musici del Concerto, che Baglione avrà descritto altrettanto in casa del cardinale Del Monte, cogliendovi Marino la figura retorica dell’erma di Giano, un busto immortale la sua mezza figura, anche nelle due teste di musicanti a figura intera abbinate e quasi bifronti à pendant, come aveva osservato Cesare Brandi. La concordanza delle diverse testimonianze nelle rispettive memorie imporrebbe che tanto la Medusa, quanto il Suonatore di liuto ed il Concerto, come il Ragazzo morso dal ramarro (fig.18), più che probabilmente entrambe le due versioni, si fossero trovati nel 1597 nello studio romano del Cavalier d’Arpino, anno in cui Gaspare Murtola scrisse l’“Epithalamio nelle nozze di Don Filippo Colonna, è della Signora Donna Lucrezia Tomacelli.” Nel corso dell’anno Marino era a Napoli al servizio di Matteo di Capua, principe di Conca, come ribadito dal biografo Angelo Borzelli (Napoli 1906) e non è documentabile che li avesse visti a questa data, ma nemmeno il contrario, ed è certo che appartenessero al primo gruppo di opere realizzate da Caravaggio con il Bacchino malato ed il Fruttarolo della Galleria Borghese e con il Canestro di frutta della Pinacoteca Ambrosiana, così come nel XX secolo avranno sostenuto tanto Roberto Longhi che Lionello Venturi.
Che la genesi della Giudit del Ritratto biblico di Marino fosse contemporanea all’idea stessa di Caravaggio del lenzuolo insanguinato dal cadavere di Oloferne e della sua “squallida chioma” afferrata dalla giovane donna nell’atto di staccargli la testa (Galleria Barberini, Roma), d’altra parte, implicherebbe che il poeta in prima persona fosse stato a Napoli, dove il quadro si trovava, altrimenti documentato nello studio del pittore nel 1607 (ASMN, Corrispondenza ducale Gonzaga, Esterni, XXV, 15 e 25 settembre 1607, Lettere di Ottavio Gentili e di Frans Pourbus), e come in effetti nel 1606, nei suoi spostamenti da Ravenna, era avvenuto. E dove, l’Oloferne di Caravaggio, oltre ad avervelo veduto anche Annibale Carracci, fu copiato da Louis Finson (Palazzo Zevallos, Napoli) e questa volta l'originale conteso a Napoli, dipinto per i Costa a parere di Baglione, requisito da Ottavio nel 1609 al pittore Pietro Contini di Parione, rivendicandone l'autografia negli inventari del 1632 e del 1639. Constatazione di rilievo che vorrebbe Finson copista fedele a Napoli dell’Oloferno e della vecchia Abra di Frans Pourbus, al quale oscilla l’esemplare reso noto a Tolosa nel 2015, e proprio per il Principe Matteo di Capua, del quale Pourbus stimava le collezioni: il fatto che fosse a Napoli nel 1607 lascia supporre Artemisia Gentileschi come fortuita modella della Judith, sola a riprodurne il gesto delle braccia nelle sue tele che ne riprendono l’idea, inscenandola. Nel titolo Marino non fa parola di un pittore, lasciando volutamente anonima l’immagine della biblica “Giudit” di Betulia, ma calzante l’originale caravaggesco e la sua stretta della chioma di Oloferne[2], così diversa dalla pur prediletta ‘Giudit’ di Cristofano Allori (Uffizi, Firenze) con la sola testa del sovrano barbaro, tra i dipinti più famosi del Seicento fiorentino e nel formato tardomanieristico che era anche di Lavinia Fontana (Museo Davia Bargellini, Bologna).
Per accompagnare una Susanna di Caravaggio in suo possesso, Marino chiese da Parigi nel 1620 (Giambattista Marino, Epistolario, Bari 1911, CLXIII, p. 281) una copia della Giudit di Allori per se’ al padre Paolino Berti, priore del Convento di S. Agostino di Lucca e le due immagini di soggetti biblici femminili dovevano essere l’una accanto all’altra nella consistenza della collezione privata del poeta, senza necessariamente esservi ‘a’ pendant’. Per la chiesa lucchese di S. Agostino era Francesco Vanni ad aver eseguito ancora una pala d’altare con l’Annunciazione (Cesare Franciotti, Historie delle miracolose immagini, Lucca 1613, p. 545), ma nel 1616 l’agostiniano padre Berti era stato priore del Convento di S. Giacomo Maggiore di Soprarno a Firenze (Angelo Grillo, Delle Lettere del Reverend.mo Padre Abbate D. Angelo Grillo. 3, Venezia 1616, p. 337) ed è probabilmente la Vergine Annunciata con un angelo di Vanni, alle Gallerie dell’Accademia di Firenze, ad avere ora un’attribuzione meno convincente ad Alessandro Allori. Marino doveva aver incontrato l’uno e gli altri a Firenze e certo, come Vanni, aveva potuto osservare l’attitudine della Madonna di Loreto di Caravaggio nella chiesa di S. Agostino a Roma nel 1604.
Il Ritratto di Susanna (fig.19) de La Galeria di Marino rafforza la repulsione del desiderio contronatura dei vecchi pretendenti, che sono fuori campo, con la predisposizione alla sofferenza di una martire schifata, mentre è diabolicamente tentata: “Lunge, deh lunge, alcun non s’avicini,/ Vecchi impudici, a questa fonte pura./ Son trà gli humori algenti e christallini,/ Onde s’accende in voi sì stolta arsura?/...Pria ch’io da voi riceva ingiurie, & onte./ farò qui del mio sangue un altro fonte.” Marino aveva ricevuto in dono, speditogli per posta, il San Giovanni di Cristofano Allori, e non ottenne la Giuditta, nemmeno una seconda versione, anche se la debolezza per questo dipinto è uno dei punti di contatto ravvicinato della sua poetica con il conte di Villamediana. Dopo la morte dell’Allori nel 1621, il San Giovanni e la Giuditta erano entrati a far parte della Guardaroba medicea e nel 1666 della raccolta di Carlo dei Medici, ma Marino e’ stato ed e’ ugualmente, in parte misconosciuto dal crocianesimo, il piu’ acuto interprete del realismo neolatino di Caravaggio e dei Carracci, piu’ coinvolto, burlesco e persuasivo degli accademici Giovanni Baglione e Joachim von Sandrart, ma anche di Giulio Mancini, che della Susanna (fig.18), un putto punto da una spina, o morso da un racano, o da una lucertola, parlarono altrimenti. Gli effetti di luce sulla caraffa di fiori, notati dai biografi, anche copiando l’uno dall’altro nei rispettivi passi pertinenti, sono rispondenti al riverbero della luce proveniente da una finestra posta alla sinistra della caraffa attraverso la trasparenza dell’acqua, che avrà maggiore o minore incidenza a seconda delle variabili indipendenti dell’altezza della sua luce e della distanza cui è posto l’osservatore (cioé il pittore) - certo non le stesse in tutti i quadri in cui abbia dipinto una caraffa - ed in secondo luogo la rifrazione sul pelo dell’acqua, appena un ispessimento dei gambi dei fiori: forse abbastanza per poter dire che le due versioni fossero state realizzate contemporaneamente. Il che non escluderebbe che il Ritratto del Cavalier Giovan Battista Marino e di Crescenzo Crescenzi 'ambo facti per manus di Caravaggi', per il primo dei quali in realtà avrebbe posato il Crescenzi, del lascito testamentale di Crescenzo Crescenzi al nipote Francesco del 1641 (AST) fossero proprio la sua Susanna, emblematica del raccapriccio. Il piccolo rettile, uno scultoreo tritone nel Caravaggio, era un raccapricciante serpente nella seduzione anche della Susanna di Alessandro Allori (Musée Magnin, Dijon).

Fig. 19 - Caravaggio, Susanna (?) (Fondazione Longhi, Firenze)
Per non tacere l’assenza, nel vastissimo panorama del volume presentato, di una trattazione specifica sulla Galleria Farnese dei Carracci, c’è da dire che il riferimento costante alla sua ideologia non è senz’altro sfuggito agli autori, né potrebbe essere tale, dato che molte delle favole mitologiche di Marino sono le stesse che s’individuano nel celeberrimo soffitto di Palazzo Farnese. Una in particolare fa sentire la sua mancanza nello sviluppo enciclopedico di questo nuovo libro sull’argomento mariniano più immaginativo e non sempre al di fuori del romanzo fantastico ariostesco, come precisato dai suoi autori: Aci con Galatea. E’ noto che Marino ricevette in dono da Giuseppe Cesari D’Arpino il disegno di Galatea che si trova all’École de Beaux Arts di Parigi e che consentirebbe di visualizzare lo sconosciuto dipinto della Galatea di D’Arpino, esemplarmente precedente per contrasto il “Polifemo con Galathea d’Agostino Carracci” nelle Favole di Marino. Ne’ dovrebbe sorprendere l’accostamento, infatti, se potrebbe dirsi che non ci sia pittore barocco che non abbia dipinto Galatea - dalle quadrature di Agostino Tassi a Palazzo Lancellotti a Roma a Francesco Albani a Palazzo Verospi, riferiti all’esecuzione di Sisto Badalocchio -, può dirsi anche che miriadi di anonimi Aci abbiano costellato i nastri di affreschi palatini non solo romani. Tra questi probabilmente quello con il quale venne avviata la decorazione della Sala di Bacco, già Sala di Ovidio del Palazzo Pamphilj a Piazza Navona (fig. 20), ciclo schedato in blocco a Giacinto Brandi, e cui pure corrisponde, invece, ancora un “Aci con Galathea di Pier Francesco Morazzoni” di Marino: il Mazzucchelli caro al poeta per aver dipinto un “Adone morto”, ucciso dal cinghiale e pianto da Venere, com’era stato illustrato il mito da Vincenzo Cartari ne Le Immagini de i dèi de gli antichi (Venezia 1571), e nemmeno questo quadro è ritrovato nel nostro volume.

Fig.20a - Giuseppe Cesari D'Arpino, Galatea, Aci e Polifemo, b - Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, Polifemo, Aci e Galatea (Palazzo Pamphilj a Piazza Navona, Roma, affresco)
A meno che non lo si voglia riconoscere, per inciso, nel dipinto grande in collezione privata (fig.21), battuto ad un’asta di Christie’s nel 2006 a Palma il Giovane (cm.169,5x120,5), e, come tale, pubblicato ancora (figura 3 alla pagina 259) da Emilio Russo, che non dovrebbe essere visto isolatamente dalla sfera d’influenza mantovana di Rubens ed in cui compaiono ai piedi di Venere le colombe e non i cigni tra gli “augei canori” attributo della dea. Ancora piu’ vicino anche all’ottava de L’Adone (XVIII, 99), in cui Morazzoni e’ nuovamente citato ed in cui le “vive carte”, nelle quali Marino liricamente s’identifica, dietro le immagini di Cartàri, sarebbero proprio le Metamorfosi di Ovidio, in cui il mito e’ narrato per intero, fino alla mutazione nel fiore dell’anemone (la rosa rossa la sferza di Cupido) delle gocce di sangue del giovane.

Fig.21 - Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, Venere piange la morte di Adone (collezione privata)
Tanto piu’ se e’ vero che Jacopo Palma il Giovane aveva dipinto Venere e Adone, con Marte (fig.22), di cui parlò Carlo Ridolfi ne Le Meraviglie dell'arte (Venezia 1648), e sullo sfondo le figure di una Parca e di Crono, allegorici del suo destino di precaria rinascita, in un sincretismo diverso dalle istruzioni impartitegli da Marino nella Lettera a Ciotti: opera conservata nel Museo Pio di Carpi (Musei Civici, Carpi, Modena) e con movenze cui si riferivano tanto la lettera scritta nell’ottobre 1619 (Lettera N. 133 ed. Guglielminetti) che il testo inaugurale de La Galeria. Palma inoltre esegui’ il disegno d’invenzione dell'incisione a bulino di Battista Franco dei due amanti (Gabinetto Disegni e Stampe, Accademia Carrara, Bergamo).

Fig.22 - Jacopo Negretti detto Palma il Giovane, Venere e Adone (Musei Civici di Carpi, Modena)

Fig,23 - Jacopo Zucchi, Adone dorme in grembo a Venere (Museo di Casa Vasari, Arezzo)
Ma ne La Galeria è cantato: “Adone. Che dorme in grembo a Venere di Giacomo Palma”. Un quadretto su rame depositato nel Museo di Casa Vasari ad Arezzo (fig.23), invece che a Giorgio Vasari junior, è oscillato per il formato e per alcune affinità tecnico-stilistiche ai rami della serie di Jacopo Zucchi agli Uffizi e agli altri due alla Galleria Borghese, uno dei quali, nel sincretismo dell’età dell’oro, ma ancora senza titolo, raffigura il Profeta Daniele e la manna, mentre il secondo è intitolato la “Pesca dei coralli”, così com’era descritto nella villa romana di Ferdinando Medici da Giovanni Baglione nella vita dell’allievo di Vasari (in consonanza tematica al Delle Pescatorie di Gaspare Murtola, edite nel 1617). Il quadretto, calzante l’immagine di Marino, testimonierebbe una sua frequentazione di uno Studiolo di Ferdinando dei Medici, che nella villa romana aveva un soffitto affrescato con le nove Muse, tra cui la prediletta Polimnia, di Jacopo Zucchi.
Marino conosceva Palma dagli anni romani e ne La Galeria inserì tra i ritratti l’elegia “In morte d’un figliuolo di Gacomo Palma” in cui compiangeva la morte di un figlio del pittore appena giovinetto, chiamando anche lui "Apelle" e dicendolo in preda all’afflizione al punto tale da non poter fare altro che pulire i pennelli e lavare le tele; è possibile che Jacopo non eseguisse il quadretto richiesto da un soggetto famoso di un pittore di Ferdinando dei Medici o che il quadretto fosse a Firenze.
La favola di “Adone nascente di Giovanni Valesio” de La Galeria con Venere e Cupido, presaga del destino di morte del bimbo appena nato, è dipinta sullo sfondo del quadro alla National Gallery di Londra (fig.24), che culmina in primo piano nell’abbraccio tra Adone e Venere (cm.76x132) su un minuto prato fiorito. Entrato nel museo nel 1882 come seguace di Tiziano, vi è raffigurato un dettaglio con l’arboreo parto di Mirra, attinente al giovinetto incantato in primo piano, che ha nella mano un pomo appena colto, mentre Cupido con una freccia ferisce Venere. Questo dipinto, ritenuto un Atalanta e Ippomene, è tuttavia attendibile per essere l’Adone in grembo a Venere realizzato da Palma il Giovane, e con i panni azzurri e di lacca rossa topici del soggetto, che è fino ad oggi considerato perduto, mentre sono introvabili tuttora sia il disegno, che l’incisione di Giovanni Luigi Valesio eseguiti per il relativo particolare di Mirra, lodato da Marino nell’altra poesia de La Galeria dedicata ad Adone.

Fig.24 - Jacopo Negretti detto Palma il Giovane (?), Venere e Adone (National Gallery, Londra)
Nei due riquadri degli affreschi di Palazzo Pamphilj (fig.20a, b) si rispecchiano le due favole di Marino di “Aci con Galatea di Pier Francesco Morazzoni” con Polifemo (fig.20b) che scaglia un masso sulla riva di Capo Peloro contro Aci in fuga e la Nereide che assiste trovando scampo nuda tra le braccia di un tritone e di “Galathea del Cavalier D’Arpino”, che nel disegno donato all'autore in ringraziamento della sua lode è vestita come una sibilla michelangiolesca (Marco Simone Bolzoni 2013), e nell'affresco (fig.20a) è seminuda nel flagrante abbraccio con Aci sul dorso di un delfino, quasi a formare un unico corpo come Salmace con Ermafrodito, alla vista del ciclope sullo scoglio: la flagranza della nudità di Galatea del primo e per la prima volta Galatea tra le braccia di Aci del secondo è l'invenzione che il poeta attribuisce a D'Arpino. Mazzucchelli affrescò a Roma nell'ultimo decennio del Cinquecento la cappella della Concezione di S. Silvestro nella chiesa di S. Silvestro in Capite e della sua intensa attività romana era fonte ancora una volta Giovanni Baglione ("Pier Francesco Moranzone" p. 185).
Dando per scontato che ognuno dei modelli pittorici prescelti per il contrapposto di Galatea avesse illustrato il mito ovidiano diversamente l’uno dall’altro, nella poesia dedicata ai Carracci l’autore allude invece ai due dipinti di Polifemo e Galatea nella Galleria Farnese, il primo dei quali, in cui Galatea nel profondo scorcio è nascosta dal nudo di spalle di Aci, attribuiva interamente ad Agostino Carracci. I due affreschi della volta Farnese sulle pareti corte erano compiuti nel primo semestre del 1600, anno alla fine del quale il poeta lascio’ la casa del conte Matteo di Capua a Napoli per rifugiarsi a Roma, in casa Crescenzi, e non vi è ragione di dubitare che la sua satira ne avesse e ne avrebbe riavuto una conoscenza telescopica, testimoniando che i due riquadri fossero la Galatea nella Galleria e che non ve ne fossero tre dei Carracci sul medesimo argomento. Un testo che fa comprendere quanto lontana nel tempo fosse la gestazione della Galeria di Marino, almeno da quando aveva composto, nel favore del cardinale Odoardo Farnese e al servizio di Melchiorre Crescenzi, l’Epithalamio per il matrimonio di Ranuccio Farnese e Margherita Aldobrandini, celebrato dal pontefice nella Cappella Sistina, e incluso nella raccolta Epithalami, edita nel 1616, ed il dimenticato idillio del Polifemo cieco. E sottintende che il ridicolo farsesco dei due affreschi fosse dipeso proprio dal non essersi avvalsi i due pittori in ogni modo di alcun suo consiglio, sdoppiando l’argomento del gigante dello scenario della Sala di Galatea di Villa Farnesina, che era in due riquadri, uno dei quali solamente di Polifemo e l’altro, di Raffaello, solo di Galatea, rispetto ai quali a ritroso, più che ai contemporanei D’Arpino e Morazzone, vuole spingersi l’arguzia del contrappunto. Svelava da intenditore nel Polifemo, Galatea e Aci di Giulio Romano nella Sala di Psiche del Palazzo Te’ a Mantova la fonte d’immagine dei Carracci, sdoppiata nella Galleria Farnese. Lo strale era rivolto a Il Polifemo. Stanze Pastorali di Tommaso Stigliani, dedicato a Ferrante Gonzaga Principe di Molfetta, il cui prologo recitava: “Con più d’una vezzosa altra compagna/ Di bianco viso, e di dorata chioma, Galatea gia notando; e in mezo à quelle/ Rassembrava la Luna infra le stelle.” Nel dipinto di Annibale della Farnese, infatti, Galatea sulla conchiglia trainata dal delfino ha nell’acqua anche due Nereidi a fianco a sé.
Marino aveva composto a Napoli alcune Rime edite a Venezia nel 1602, tanto le Marittime, quanto le Boscherecce, in cui e’ il mito di Polifemo e Galatea, dedicando il canzoniere nel Racconto ai rispettivi signori, anche napoletani, per i quali era stato composto e alla località paesaggistica occasione dello spunto poetico, ma è pure vero che moltissimi luoghi di cui parlava non li aveva mai visti in vita sua. Tornerà sempre sull’argomento, come e’ attestato dalle Vite di Giovan Battista Passeri, chiedendo nel 1624 ad Alessandro Turchi detto l’Orbetto un dipinto di Polifemo e Galatea, che sarebbe rimasto nella Galleria Borghese, dove Turchi era attendente.
Per raggiungere il termine ‘ante quem non’ della genesi della Galeria, sostrato iperbolico del libro presentato nel suo complesso, ma forse non abbastanza, sarà utile focalizzare ancora il campo del canzoniere mariniano delle Rime, riedite nel 1604 e, sulle note biografiche di Giovan Battista Baiacca del 1625 (Carminati 2018), ripubblicate postume nell’edizione de L’Adone del 1627, e a partire dal 1590, anno di pubblicazione non solo dell’Idea di Lomazzo, ma della prima edizione illustrata, edita a Genova da Girolamo Bartoli (BAV), con le figure di Bernardo Castello, e di Agostino Carracci e Giacomo Franco, della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, nei cui scenari costantemente incombe una turrita Gerusalemme. Marino ferito era approdato nel palazzo del cardinale Ascanio Colonna a SS. Apostoli e vi conobbe Gaspare Salviani, accademico umorista che scrisse le Dichiarazioni alla Secchia rapita di Alessandro Tassoni, e suo fratello Ippolito, archiatra, succeduto al padre nel Collegio dei medici di S. Spirito, dove e’ solo presumibile conoscesse Giulio Mancini, ma da Salviani e’ certo che fosse stato presentato a Melchiorre Crescenzi nel 1600. Nei suoi viaggi a Venezia era stato ospitato già piu’ di una volta dai conti Barbazza a Bologna, presso i quali poté incontrare l’accademico Gelato Rodolfo Campeggi ed affermarsi anche in quella città e presso la legazione di Ferrara del giovane cardinale Pietro Aldobrandini.
E’ plausibile che l’ambientazione topografica delle lunette Aldobrandini di Annibale Carracci (Galleria Doria Pamphilj, Roma) che collocano gli episodi della storia cristiana sulle rovine romane coincida con l’analogo ‘topos’ delle Rime di situare le favole in luoghi determinati della memoria dell’antico. Nelle due lunette carraccesche dalla rinomata raccolta del cardinale della Fuga in Egitto e della Sepoltura di Cristo, che non furono poste nella Cappella Aldobrandini in S. Maria sopra Minerva, e nemmeno nella cappella di famiglia in S. Maria in Via o nell’omonima cappella del Monte di Pieta’, compaiono nel paesaggio le vedute del Pantheon e, invece di Gerusalemme, dietro il Golgota, delle Mura di Roma nel tratto delle Porte Latina e Porta S. Sebastiano, sulla Via Appia antica: lasciando supporre che furono dipinte per la cappella del palazzo di Giovan Francesco Aldobrandini, padre di Margherita, al Pozzo delle Cornacchie al Pantheon (Maria Barbara Guerrieri Borsoi 2007), che inglobava un’esedra delle Terme Alessandrine, raffigurando nell’altra scena il capitolo di S. Sebastiano, cui apparteneva la proprietà del Casale di Torre Nuova appena sequestrato alla famiglia Cenci. Nelle lunette Annibale appare quanto mai lontano dagli scorci di paesaggio affrescati dal viterbese Prospero Orsi nel palazzo appartenuto al cardinale Tiberio Crispo sul Lago di Bolsena, dove soggiornarono gli Aldobrandini, che nel 1600 erano anche in possesso della Villa Este, avuta dai Vitelli, a Monte Magnanapoli. Il paesaggio dei Carracci e’ tutt’altro che fantastico: e’ il pittoresco dell'immaginazione mariniana, dove il monumento storico, precisamente decontestualizzato e anacronistico, è innalzato a simbolo.
Non solo i Carracci, anche la bolognese Lavinia Fontana era pittrice sbalorditiva ammirata da Marino, conosciuta negli anni romani al servizio del cardinale Pietro Aldobrandini. Della sua discendenza da Prospero Fontana aveva parlato Baglione, ma la sua Erodiade cantata dal poeta barocco e’ celata da una sorta di sospetto, che nemmeno ha sfiorato finora la coincidenza al Banchetto di Erode (fig.25), che oggi porta l’attribuzione a Mattia Preti (Toledo Art Museum, Ohio). Marino canta in cinque differenti sonetti, Ritratti di Erode e Historie di Erodiade, la tragedia biblica del divorzio e del matrimonio doppiamente incestuoso di Erode Antipa, senza esitazioni l’omicida e amante di Erodiade, la bella ebrea, sorellastra e moglie del fratello. Nel dipinto di Lavinia la figlia di Erodiade, che Flavio Giuseppe avra’ detto chiamarsi Salome’, e’ la “Danzatrice Hebrea”, per antonomasia comprensibile a chiunque: Marino mostra di conoscere la truce vicenda della decollazione di Giovanni Battista dei Vangeli nei particolari del racconto delle Antichità Giudaiche di Flavio Giuseppe, ricordando perfino il nome della madre di Erode, Mariamne, la vecchia che compare in molti dipinti, moglie ripudiata da Erode il Grande.

Fig. 25 - Lavinia Fontana, attr., Festino di Erode (Toledo Art Museum, Toledo, Ohio)
Nei due episodi della scena dalle Storie di S. Giovanni Battista dipinti da Mattia Preti nelle notizie della Vita del pittore di Bernardo De Dominici (Vita del Cavalier Fra Mattia Preti detto il Cavalier Calabrese) era precisata essere presente al festino, almeno nella tela dalla raccolta di Antonio Caputo a Napoli, la figura dell’anziana donna, che nel quadro del Toledo Art Museum e’ alle spalle di Erodiade.
Tuttavia questo quadro (cm.178x262), oltre ad esservi l’ebbro Erode (fig.25) deliziosamente vicino al fare della Fontana, che Marino considerava prototipale, e’ troppo grande per accompagnarlo (la tela è descritta nel testo “di misura di poco più di quattro palmi per alto, e di poco più di tre per traverso”, p. 341, supponendo la posposizione della dimensione maggiore) alle tele del Tributo della moneta di Preti e, in particolare, quella della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini (cm.123x173) a Roma. Scopo per il quale lo stesso soggetto fu dipinto da Preti ed inviato da Malta - dove nuovamente affrescò le Storie di S. Giovanni Battista nell’omonima Cocattedrale di La Valletta - a Napoli. Ed è troppo piccolo per far parte della serie grande (“in tele di quattordeci e nove palmi per traverso”, p. 344) delle Storie del Santo dipinte da Preti per Ferdinando Vandeneynden che, mentre De Dominici scriveva, si trovavano nella collezione del principe Carlo V Carafa di Belvedere, descrivendole lo storico ciascuna larga quattordici palmi napoletani, circa tre metri. Di spalle la figura della vecchia Mariamne in un’altra tela col Festino di Erode (fig.26) nelle stesse proporzioni (cm. 170,5x260,5) di Mattia Preti, censita nella Gemäldegalerie Alte Meister di Kassel, ne è privo il medesimo soggetto dipinto per la serie da Pieter Paul Rubens e alla National Gallery of Scotland e anche, di grandi proporzioni, il Festino di Erode di Preti della Galleria Doria Pamphilj di Roma (cm.2,43x4.10) noto come Concerto, in cui danzerà Salome, di spalle di fronte a Erodiade, che testimonia solo il soggetto Caputo di Preti con la figura di vecchia, in tutt'altro cromatismo dal dipinto di Toledo.

Fig. 26 - Mattia Preti, Festino di Erode (Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel)
Guido Reni nella Salome’ concentrò le mense reali di Erode, a differenza dei quadri finora presunti irreperibili sia di Annibale Carracci che di Lavinia Fontana (La Galeria, p. 56-57), senonche’ ancora fraintesi nelle due rispettive storie mariniane, nell’unico piatto porto a passo di danza dalla sua archetipica Salome’ con la testa del Battista (Galleria nazionale d’arte antica Corsini, Roma). Il soggetto di Reni connesso, quindi, alla terza “Historia” di Marino del quadro di Luca Cambiaso della testa del Battista su un piatto della collezione di Giovan Carlo Doria, “immobil sasso”, con la colpevole mano che (La Galeria, p. 57): “E’ Medusa ben quella/ Che in man l’accoglie, in un crudele, e bella;/ Cagion che il tronco suo di vita casso/ Rimase immobil sasso.” Vi è, cioé, letteralmente descritta mentre scende sul piatto sorretto da Salome’, come nel dipinto privo di ombre del Metropolitan Museum di New York (fig.27). Il quadro, sulla fascia marmorizzata in basso a destra, reca la firma, altrettanto solo probabilmente originale, a lettere capitali: ‘Andreas de Solaris f.’, ma eseguito dal più tardo pittore di Augsburg Christoph Amberger (‘Christoph Amberger pinxit’) l’analogo soggetto del Kunsthistorisches Museum di Vienna che l’incisione (fig.28) di Anton Joseph Prenner (Prenner Gal. Vienne) della Galleria Imperiale (Theatrum artis pictoriae, 1728) riproduce, e che ritrova sempre la struttura tizianesca del ritratto storico.

Fig. 27 - Andrea Solario, attr., Salomé con la testa del Battista (Metropolitan Museum, New York)

Fig. 28 - Anton Joseph Prenner, da Christoph Amberger, Salomé (British Museum, Londra)
Il ritratto storico di Salome’ a mezza figura di Reni (Galleria nazionale d’arte antica Corsini, Roma) di una ballerina col turbante, tratto dal racconto della Passione della Legenda aurea di Jacopo da Varazze, era esaltata dal busto femminile della Buona Ventura di Caravaggio e dal realistico tonfo disperato sulla sedia della giovane donna piangente di Caravaggio, l’angoscia di ogni donna tentata alla Galleria Doria Pamphilj a Roma, che aveva trovato nelle Lagrime di S. Maria Maddalena (1587) di Giovan Battista Attendolo di Capua lo spirito pietistico controriformato pertinente l’interpretazione iconografica della Lavanda dei piedi di Cristo della Santa, pur sempre una “Maddalena piangente”. Anche dove sono piu’ ossessive le precisazioni di Marino sugli oggetti artistici piu’ amati nello Zibaldone e nelle Lettere, la rocambolesca avventura del loro successo collezionistico li lega sempre piu’ inscindibilmente alla fortuna storica e dinastica nello stile dei loro acquirenti, anche romani, quando e’ possibile coglierla direttamente dalle sue parole. Per quante Maddalene avesse dipinto Raffaello non sembra possa ancora indeterminarsi che la “Madalena piangente di Rafaello da Urbino” (p. 77) ne La Galeria fosse la Deposizione Baglioni, in cui la Santa sembra lievitare al cielo, sola nel compianto di Cristo: la pala era giunta da Perugia a Roma nel 1608 nella raccolta di Scipione Borghese. Ne La Galeria rappresenta il contrappunto armonico al compianto di Maddalena della Basilica di S. Maria Assunta di Carignano a Genova, la Pietà di Luca Cambiaso (p. 77).
Alle varie fortune di Tasso nelle dimore del Principe di Conca Matteo di Capua e alle immagini dei maestri del Rinascimento della sua pinacoteca Marino deve il proprio itinerario d’arte e la prima informazione sulle quadrerie estensi e Farnese. Nel 1598 compose le stanze dedicate alla Maddalena di Tiziano (Museo di Capodimonte, Napoli), riedite ne La Galeria, ed e’ con il paziente lavoro di questo volume che ci avviciniamo ancora una volta a capire che, non meno della ‘maniera’ di Filostrato, ed è stato da tempo osservato che il suo Filostrato fosse affinato sull’edizione parigina del 1615 de Les Imagines ou tableaux de platte peinture tradotte e commentate da Blaise de Vigenère, La Galeria sia un museo esistito di tesori, legati l’uno all’altro per il fatto di essere stati taciuti, raffinatamente censurati. In più di una lettera nel corso del tempo aveva discorso della propria casa nel sole di Napoli dove raccogliere un museo fatto di libri, di dipinti e, in pieno narcisismo, di elogi dei personaggi da lui conosciuti che avrebbero anche avuto la supremazia sui grandi del passato. Non certo indifferente al Museo incompiuto di Giovan Battista Attendolo di Capua che bilanciava nei due principi dei Toscani e dei Latini la materia poetica (Napoli 1613). O perché la stima di Rubens di Marino si debba identificare nell’Atalanta e Meleagro del Metropolitan Museum of Art di New York e non piuttosto con le copie di Monaco o di Kassel, o perché l’idea della Salome’ sia di Luca Cambiaso e non di Andrea Solario, ma soprattutto perché, con questo invito alla lettura, apparira’ improbabile neanche

Fig. 29 - Cherubino Alberti dal Borgo, Pallade e Aracne, Sala dei Lanifici (Palazzo Farnese, Caprarola)
accostare, tra le altre mirabili Favole, ai versi dell’ “Aracne con Minerva di Cherubino dal Borgo” la Pallade e Aracne (fig.29), che si alza in volo in un bozzolo di ragno, della Sala dei Lanifici del celebrato Palazzo Farnese di Caprarola, se non altro per restituirla alla personalità di Cherubino Alberti da Borgo San Sepolcro, dipinta in competizione e a paragone almeno con le immagini esaltate come parola divina di un grande come Taddeo Zuccari. Ogni nuovo frammento che si aggiunge allo sconfinato mosaico de La Galeria rende Marino sempre più attendibile e autentico. Senza la sua iconologia dello stravagante e dell’inverosimile, fatta del gioco onomastico della piu’ pura retorica, forse gli stessi immensi cataloghi della pittura pompeiana e della Galleria Farnese sarebbero, se non “razzolando col detto ronciglione” nel più eccentrico eloquio, ancora segreta emulazione.
A questa poderosa ricerca, che non voleva esserlo, ma è esaustiva sul piano della modernità della cultura barocca, ci sarà da aggiungere, e gli autori ne sono consapevoli, partendo dal suo solido nucleo, opera per opera, su ogni singolo bene culturale che vi abbia fatto storia. Marino, insuperabile, esagerato poeta maledetto, non suscita solo meraviglia, è sbigottito dalle immagini create dalla verità più inaccessibile: di mano in mano la finzione più assurda le fa veritiere, snaturate. L’osservazione lenticolare nell’ossessione di conservare l’arte da una vita fuggitiva, quanto mai attuale, è l’ubiquità dell'immagine nell’infinitezza del suo ovidiano “materiam superabat opus.”
[1] Riccado Gandolfi, Le Vite degli artisti di Gaspare Celio, Firenze 2021.
[2] Aperta il 26 novembre scorso a Roma, Palazzo Barberini, Gallerie nazionali di arte antica la mostra “Caravaggio e Artemisia: la sfida di Artemisia. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento”, a cura di Maria Cristina Terzaghi.
Copia qui lo "short link" a questo articolo
www.archeomatica.it/{sh404sef_shurl}


