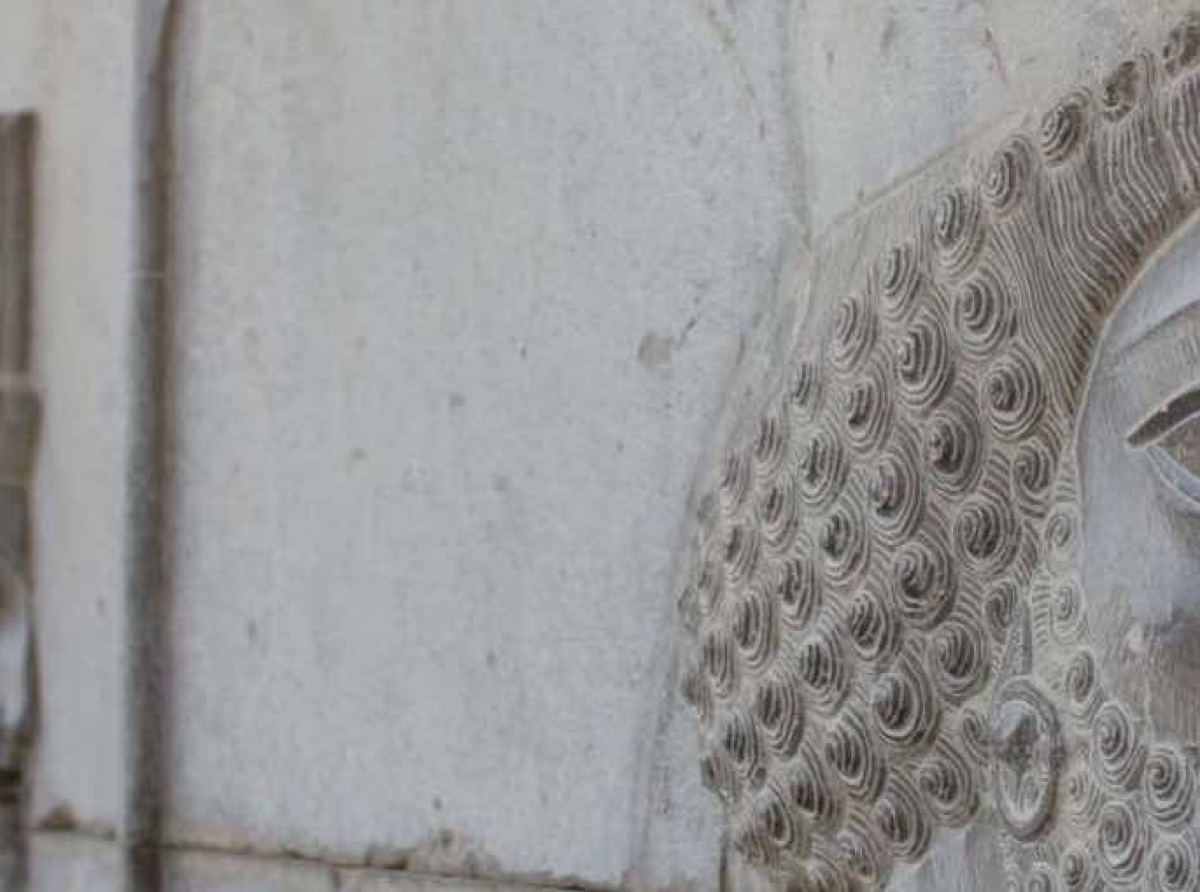La University of Leicester, in collaborazione con il Libyan Department of Antiquities, ha sviluppato uno strumento innovativo destinato a rivoluzionare il monitoraggio e la tutela dei siti culturali a rischio, in particolare di quelli archeologici. Il sistema, denominato EAMENA Machine Learning Automated Change Detection (MLACD), rappresenta un avanzamento significativo nel settore, grazie all’uso di algoritmi di machine learning e immagini satellitari.
Guidato dai ricercatori Ahmed Mutasim Abdalla Mahmoud e Nichole Sheldrick, in sinergia con Muftah Ahmed, è stato presentato in un articolo pubblicato nel numero di gennaio 2025 della rivista Remote Sensing Applications: Society and Environment (vol. 37, articolo 101396) (Elsevier). Al centro dell’innovazione risiede l’uso del Google Earth Engine (GEE), una piattaforma cloud che consente di elaborare grandi quantità di dati geospaziali in modo rapido ed efficiente. Il MLACD è stato progettato per essere accessibile anche ai professionisti privi di competenze avanzate di programmazione, grazie a un’interfaccia intuitiva e ad una documentazione disponibile in inglese e arabo. Utilizzando sequenze temporali di immagini satellitari, il sistema identifica cambiamenti territoriali — come nuove costruzioni, degrado ambientale o espansioni agricole — che potrebbero minacciare i siti archeologici.
Validazione e prestazioni
La validità dello strumento è stata dimostrata attraverso uno studio condotto nella regione di Bani Walid, in Libia, un’area caratterizzata da significative testimonianze storiche esposte a rischi quali urbanizzazione, agricoltura intensiva e degrado ambientale. Analizzando 135 immagini satellitari Sentinel-2 acquisite tra il 2019 e il 2024, il MLACD ha raggiunto un’accuratezza superiore al 96%. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impiego del classificatore Random Forest, particolarmente efficace in contesti aridi, dove le caratteristiche spettrali facilitano una distinzione chiara tra i diversi elementi del paesaggio.
Vantaggi e prospettive
Uno dei principali punti di forza del MLACD è la sua capacità di effettuare analisi su larga scala in tempi ridotti, riducendo significativamente il carico di lavoro per i professionisti del settore. Questo approccio permette di monitorare simultaneamente decine di siti archeologici, stabilendo priorità d’intervento e ottimizzando risorse spesso limitate. La possibilità di integrare analisi storiche e in tempo reale consente di pianificare interventi di conservazione più mirati e prevenire futuri danni. Il sistema, inoltre, dimostra una versatilità che lo rende applicabile anche ad altri ambiti, come il monitoraggio della deforestazione, l’erosione costiera e gli incendi boschivi.
Sfide e limiti
Nonostante i numerosi vantaggi, il MLACD presenta alcune limitazioni. La risoluzione spaziale di 10 metri per pixel delle immagini Sentinel-2 può non essere sufficiente per rilevare cambiamenti di piccola scala, come saccheggi puntuali o danni lievi. Sebbene l’uso di immagini a risoluzione più elevata possa mitigare questo problema, comporta un aumento significativo del carico computazionale. Inoltre, variazioni stagionali possono generare falsi positivi, richiedendo dataset di addestramento più ampi e diversificati per ridurre gli errori di classificazione. Gli autori dello studio suggeriscono che l’integrazione di nuovi set di dati multispettrali o radar, unita a tecniche di calibrazione più avanzate, possa superare molte di queste sfide.
Prospettive future
Il MLACD si presenta come uno strumento modulare, facilmente adattabile a diverse scale di applicazione — regionale, nazionale o globale. All’interno del progetto EAMENA sono già in corso sperimentazioni in Algeria, Marocco e altre aree del Nord Africa, con risultati che saranno pubblicati prossimamente. Un aspetto cruciale è la formazione di esperti locali attraverso corsi e workshop, per garantire una corretta implementazione della tecnologia e una sua integrazione nei flussi di lavoro delle autorità preposte alla tutela.
Conclusioni
Il MLACD non rappresenta solo un progresso tecnologico, ma un autentico cambio di paradigma nella protezione del patrimonio culturale. Il lavoro di Mahmoud e colleghi dimostra come l’unione tra innovazione tecnologica e cooperazione sul campo possa rispondere efficacemente alle sfide globali legate alla conservazione dei siti archeologici. Questo strumento offre una nuova prospettiva per la gestione del nostro patrimonio culturale, promuovendo un equilibrio tra modernità tecnologica e salvaguardia del passato per le generazioni future.